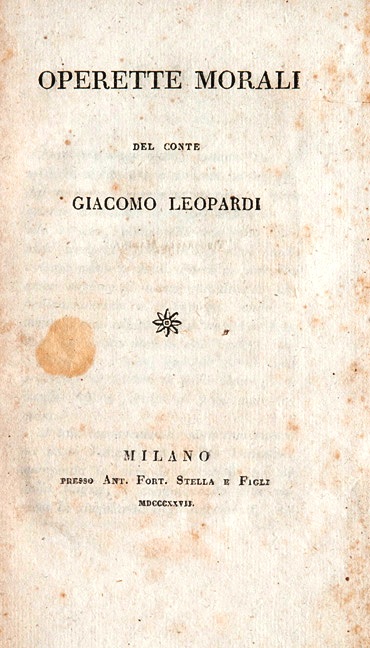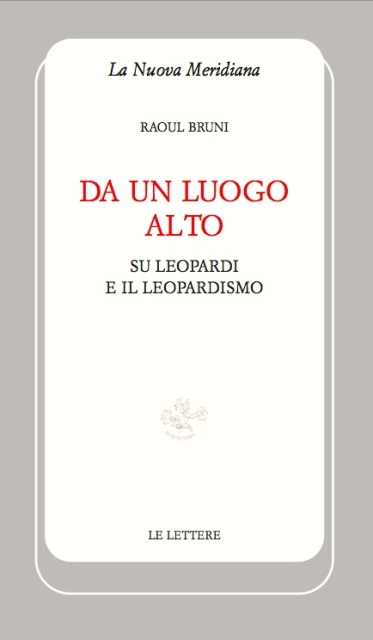Parrà strano, ma nell’ormai smisurata bibliografia critica leopardiana non si trova ancora una spiegazione adeguata e convincente delle ragioni che indussero Leopardi ad intitolare il suo capolavoro prosastico Operette morali. Mi riferisco specialmente a quell’aggettivo «morali», così chiaramente esibito nel titolo, che, come la lettera di un celebre racconto di Poe, è stato finora eluso o comunque non sufficientemente chiarito nel suo particolare significato, perfino negli studi più specifici e approfonditi sulle Operette. Tutt’al più è fatto riferimento ad Isocrate, autore a sua volta di alcune «operette morali», che Leopardi aveva tradotto nello stesso periodo nel quale elaborava le sue proprie prose morali[1]. Benché il riferimento al retore greco sia certamente opportuno, esso non basta certamente a rendere ragione del significato filosofico, assolutamente singolare, che l’aggettivo «morali» assume in Leopardi.
La preoccupazione per la filosofia morale attraversa quasi tutta l’opera leopardiana: dalle precocissime dissertazioni filosofiche, una parte consistente delle quali porta per l’appunto il titolo di «dissertazioni morali», ai pensieri zibaldoniani destinati al progetto, mai portato a termine, di un «Manuale di filosofia pratica», senza tralasciare i «disegni letterari», tra i quali figurano interessanti, benché mai realizzati progetti come «Morale in versi, o poema didascalico sulla morale», «Galateo morale»[2], «Orazioni morali: cioè Prediche e panegirici senza Scrittura e senza teologia»[3].
Il fulcro di tutti i pensieri leopardiani sul tema della filosofia morale riguarda il concetto stesso di morale. Caso unico nell’Italia primo-ottocentesca (emblematico a tal proposito il confronto con il Manzoni delle Osservazioni sulla morale cattolica), e con più di un cinquantennio d’anticipo rispetto a Nietzsche, Leopardi mette radicalmente in discussione l’idea di una morale oggettiva e assoluta […]. Per Leopardi la morale di per se stessa è una «scienza morta», dato che non è autosufficiente e ha bisogno di trovare il suo fondamento in un’altra disciplina più solida, in particolare nella politica:
la morale è una scienza puramente speculativa, in quanto è separata dalla politica: la vita, l’azione, la pratica della morale, dipende dalla natura delle istituzioni sociali, e del reggimento della nazione: ella è una scienza morta, se la politica non cospira con lei, e non la fa regnare nella nazione. Parlate di morale quanto volete a un popolo mal governato; la morale è un detto, e la politica un fatto […] (Zib. 311, 9 novembre 1820).
Sennonché la base politica che salvaguardava la sussistenza della morale si è ormai disgregata insieme a quel mondo antico che Leopardi, non a caso, non cesserà mai di considerare, dalle prime alle ultime pagine del suo diario intellettuale, nonché nelle stesse Operette[4], come superiore al mondo moderno.
Nel mondo moderno, come si legge nella proto-operetta Novella. Senofonte e Niccolò Machiavello, la virtù si è ormai ridotta ad essere soltanto «il patrimonio dei coglioni»[5], tant’è che, come recita un acuminato frammento zibaldoniano: «Oggi non può scegliere il cammino della virtù se non il pazzo, o il timido e vile, o il debole e misero» (Zib. 978, 23 aprile 1821). Il nucleo embrionale delle Operette nasce per l’appunto dalla volontà dell’autore di «vendicar[si] del mondo, e quasi anche della virtù»[6]. Com’è stato osservato, Leopardi sembra giungere in questo senso a conclusioni non troppo lontane da quelle di un Sade[7], giungendo ad identificare la virtù con l’infelicità e la miseria, e la scelleratezza con la fortuna e il trionfo (si pensi al Bruto minore o ad un altro abbozzo riconducibile alla preistoria delle Operette, il Dialogo. Galantuomo e Mondo).
La virtù nel mondo moderno è quindi scomparsa; di lei è rimato soltanto il fantasma. Non a caso, fin dall’ouverture delle Operette, la Storia del genere umano, Leopardi racconta come Giove, inviando la Verità sulla terra e lascandola dimorare lì eternamente, avesse per sempre esiliato dal nostro pianeta quei «vaghi fantasmi» – tra i quali la Virtù, la Giustizia, l’Amor patrio – che soli consentivano di rendere meno amara l’esistenza umana. Ma il testo in cui Leopardi sancisce con più radicalità il crepuscolo delle virtù morali è forse il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, da datarsi, secondo l’ipotesi filologicamente più attendibile, al 1824, lo stesso anno, quindi, in cui Leopardi compone la maggior parte delle Operette morali. Nel Discorso Leopardi denuncia infatti, senza mezzi termini, «la quasi universale estinzione o indebolimento delle credenze su cui si possano fondare i principii morali, e di tutte quelle opinioni fuor delle quali è impossibile che il giusto e l’onesto paia ragionevole, e l’esercizio della virtù degno d’un savio»[8]. Se alcune nazioni (specie quelle settentrionali), compensano parzialmente il tramonto delle virtù con il bon ton che si instaura nelle società strette (nel Discorso, come si sa, l’espressione «società stretta» ha una valenza sostanzialmente positiva), l’Italia «non solo è priva come l’altre d’ogni fondamento di morale, e d’ogni vero vincolo e principio conservatore della società. Ma oltre di questo, a differenza delle dette nazioni, ella è priva ancora di quel genere di stretta società»[9], senza la quale si cancella ogni residuo di senso civico.
A questo punto, sarà lecito chiedersi, come può Leopardi dedicarsi al progetto di un libro morale in un tempo che sembra aver abolito qualsiasi forma autentica di morale, tanto più nell’ambito di una nazione priva più di qualsiasi altra di risorse etiche, quale l’Italia del Discorso?
Intanto, come, recita un frammento dello Zibaldone, la consapevolezza della morte della morale non implica la rinuncia ad essa, almeno per coloro che: «sono fortemente morali», i quali «per quanto conoscano, e sentano e vedano, non si persuaderanno mai intimamente che la moralità non esista più, e sia del tutto esclusa dai motivi determinanti l’animo umano» (Zib. 1572-1573, 27 agosto 1821). Leopardi indica il proprio padre come esemplare di questa categoria antropologica, ma è certamente lui stesso il primo a rispecchiarsi in questo tipo di disposizione psicologica, tant’è che fino alle ultime pagine dello Zibaldone rimarrà convinto che, per quanto possa «essere disprezzata […] e chiamata vile», la virtù «è pur necessaria all’uomo, nato e destinato inesorabilmente a patire, e patire assai, e con pochi intervalli» (Zib. 4239-4240); né va dimenticata la celebrazione della virtù antica affidata agli estremi Paralipomeni della Batracomiomachia (in particolare, V, 48) […].
Ma che cosa – ecco il punto essenziale – potrà innescare un effetto morale, se la morale, secondo Leopardi, come si è visto, non può trovare il proprio fondamento in se stessa? Ebbene, ribaltando il postulato etico fondamentale del pensiero occidentale da Socrate fino a Kant, secondo il quale l’etica doveva fondarsi sulla ragione, o comunque su una conoscenza di tipo razionale, Leopardi sostiene, fin dalle prime pagine dello Zibaldone, che la morale è alimentata soprattutto dalle illusioni, dall’immaginazione, dall’entusiasmo, in una parola, dalle passioni. Quale debba essere il fondamento dell’etica Leopardi lo afferma con chiarezza in uno suo «disegno letterario» databile presumibilmente al 1820 – il progetto di un libro di argomento politico – in cui afferma, in netta contrapposizione con ogni forma di razionalismo etico, la «Necessità di render la virtù cosa amabile non per ragione ma per passione»[10].
Ma cosa può accendere la passione per Leopardi, se non la poesia? Leopardi tra il ’21 e il ’23 teorizza un’idea di poesia intesa platonicamente come passione entusiastica (si ricordi che il 1823, l’anno che precede la stesura delle Operette, Leopardi legge sistematicamente i dialoghi platonici): un’idea questa ribadita anche nell’operetta intitolata a Parini, figura di poeta etico quasi per antonomasia (si pensi anche al suo ruolo nell’Ortis foscoliano), laddove si parla di quello «istato di mobilità, senso, vigore e caldezza» che consente a certi animi di «segu[uire] ogni menomo impulso della lettura, sent[ire] vivamente ogni leggero tocco»; essi, «coll’occasione di ciò che leggono, creano in sé mille moti e mille immaginazioni, errando talora in un delirio dolcissimo, e quasi rapiti fuori di sé»[11]. […]La passione entusiastica, che è insieme origine ed effetto della poesia, secondo Leopardi, è la stessa da cui trae origine la morale: «che cosa è la virtù senza entusiasmo? e come può essere virtuoso chi non è capace di entusiasmo?» (Zib. 2157, 24 novembre 1821: in un appunto precedente aveva parlato letteralmente di «entusiasmo virtuoso», Zib. 98). Partendo da queste premesse, la risposta di Eleandro, evidente portavoce di Leopardi, a Timandro suonerà più chiara e coerente: «Se alcun libro morale potesse giovare, io penso che gioverebbero massimamente i poetici: dico poetici, prendendo questo vocabolo largamente; cioè libri destinati a muovere la immaginazione; e intendo non meno di prose che di versi»[12].
La poesia che Platone aveva giudicato immorale e pericolosa per il suo stato ideale, diviene dunque per Leopardi l’unica autentica fonte letteraria di una possibile moralità. A tal proposito, torna ancora utile citare il Discorso sui costumi degli italiani, laddove Leopardi afferma che «i popoli settentrionali e massime i più settentrionali», gli unici che, secondo lui, che abbiano conservato un qualche senso etico, sia pure nella forma degradata del bon ton, «sono oggi i più caldi di spirito, i più immaginosi in fatto, i più mobili e governabili dalle illusioni, i più sentimentali e di carattere e di spirito e di costumi, i più poeti nelle azioni e nella vita, e negli scritti e letterature»[13]. Beninteso, per Leopardi non si tratta di porre la morale alla base della poesia, secondo una vecchia concezione di matrice platonico-cristiana, bensì, al contrario, di porre la poesia (o almeno quel poco di poesia che rimane alla modernità) come argine alla definitiva disintegrazione dell’etica. Insomma: Leopardi sembra, per certi versi, anticipare la tesi di Josif Brodskij, il quale, in un suo famoso discorso, affermò che «l’estetica è la madre dell’etica»[14] […].
[1] Sulla ‘funzione’ Isocrate nelle Operette, cfr. F. D’Intino, L’immagine della voce. Leopardi, Platone e il libro morale, Venezia, Marsilio, 2009, in particolare, pp. 129-131,
[2] Prose, p. 1216.
[3] Ivi, p. 1217.
[4] «Ed aggiungo che gli antichi furono incomparabilmente più virili di noi anche ne’ sistemi di morale e di metafisica»: afferma Tristano nell’operetta succitata (Ivi, p. 215).
[5] Ivi, p. 261.
[6] «In questi giorni, quasi per vendicarmi del mondo, e quasi anche della virtù, ho immaginato e abbozzato certe prosette satiriche», G. Leopardi, Lettera a Pietro Giordani, 4 settembre 1820, in G. Leopardi, Lettere, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 2006, p. 279.
[7] Cfr., in proposito, M. A. Rigoni, Leopardi, Sade e il dio del male, in Id., Il pensiero di Leopardi, nuova edizione accresciuta, Torino, Aragno, 2010, pp. 111-120.
[8] G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, edizione diretta e introdotta da M. A. Rigoni, testo critico di M. Dondero, commento di R. Melchiori, Milano, BUR, 1998, p. 50.
[9] Ivi, p. 56.
[10] Prose, p. 1212.
[11] Ivi, p. 92.
[12] Ivi, p. 173.
[13] Discorso, p. 81(corsivo mio).
[14] Josif Brodskij, «Un volto non comune». Discorso per Premio Nobel, in Id., Dall’esilio, Milano, Adelphi, 1988, p. 47.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).