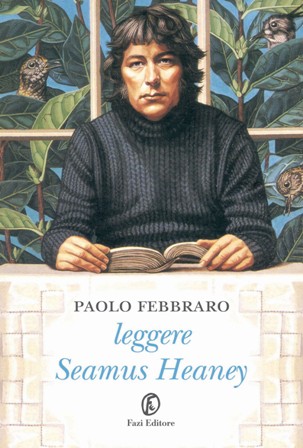Forse l’inglese percussivo e fragrante di Seamus Heaney nasce così: le percezioni tornano alla sua memoria con un’esplosività almeno pari alla scomposta freschezza con cui s’imposero alla mente prensile e mimetica del bambino che fu. Il giorno in cui c’incontrammo per l’ultima volta, nel luglio 2013 a Glanmore, ci capitò di parlare dei neuroni specchio, di quel «meccanismo di risonanza motoria» (Vittorio Gallese) che ci fa imitare mentalmente quanto percepiamo con i sensi. Le neuroscienze ci dicono che «Percepire un’azione – e comprenderne il significato – equivale a simularla internamente» (ancora Gallese). Anche il linguaggio, così, simula l’azione che descrive. Senonché, la lingua scritta è un’azione essa stessa. Tutti noi impariamo per simpatia, per accordo neuronale e riconoscimento del già noto. Viene “riflesso” dai neuroni specchio non il gesto in sé, ma il gesto riconosciuto come finalizzato a compiere un’azione: non il muovere una mano, ma l’afferrare qualcosa con la mano. Non solo: i neuroni specchio si attivano solo se sto osservando un’azione che appartiene al repertorio della mia specie. Anche capire una poesia, dunque, vuol dire riconoscerla. In qualche modo, se scrivo una poesia su mio padre che sta scavando, sto scavando anch’io con le parole.
[…] L’evidenza sensoriale dei versi di Heaney è dovuta spesso al suo modo di unire sostantivi e verbi in funzione aggettivale, quella formazione inglese delle compound words esemplificata da un verso come «That midge-veiled, high-hedged side-road where you stood». Come a dire che a volte i mattoni di Heaney sono due elementi semplici in inedita composizione, e dunque contribuiscono già di per sé a estendersi in una terza dimensione, a espandersi in altorilievo. La stessa gioia costruente-allitterante (nel verso dell’esempio, la presenza enfatica della “d”) dà l’impressione al lettore di non essere incappato in una fuga nel significante, in un compiacimento verbalistico, o insomma in un circuito chiuso, bensì di essere chiamato a un amoroso assedio all’oggetto, a una serenata per farlo venir fuori, a una sua onesta e persuasiva ripetizione. Per quanto assolutamente notevole, la lingua di Heaney non è vistosa, è anzi un’azione di maestosa servitù nei confronti della madre-esperienza. Il lettore avverte che il poeta non sta barando, che sta anzi cercando di illustrare un’azione o un’intenzione proprie della sua specie. E così, si fida.
Infatti Heaney è il grande poeta dei gesti. Non è semplicemente un realista, perché il realista guarda il mondo per denunciarne le storture e dunque per usarlo astrattamente, in modo virtuistico e moralistico. E non è nemmeno un romantico, che s’immerge in un Io irrelato o assoluto, e crea o liquefà il mondo. Il gesto, invece, è dialettica vera, è l’incontro fra il corpo e ciò che vi reagisce, lo perimetra e lo prolunga. Il gesto risale nelle fibre di chi lo compie e modifica lo strumento (sia pure l’aria) in cui lo si compie. Il gesto è un complemento di moto a luogo e di tempo continuato. Anche quando è più georgico e pastorale, Heaney è sempre, formalmente e direi filosoficamente, un poeta drammatico, che racconta i colpi inferti e subiti, le influenze trionfalmente patite, l’allargarsi centrifugo dell’esperienza e il suo rigravitare sull’Io.
Così, Heaney ha avuto il merito di non abbandonare la propria arcadia infantile, come avrebbe fatto un illuminista radicale. Del resto, gli infanti parlano coi gesti, e il corpo è un’immagine. La “pastorale irlandese” che ha vissuto nei primi anni della sua vita è diventata ciò che per altri poeti è stato il dolore, l’anaffettività della famiglia.
Tutto ciò aiuta a fare giustizia di parecchi equivoci. Per prima cosa, della poesia intesa come “scarto dalla norma”, secondo un modernismo improntato alla consumazione dei linguaggi, alla rottura degli schemi, al progressismo delle forme. L’equivoco nasce dal prendere come norma la “lingua parlata” o la prosa da giornale: come se nel linguaggio quotidiano, al mercato o a scuola o allo stadio o con il partner, non usassimo continuamente metafore e reinvenzioni del già noto, per convincere, sedurre, scusarci, coprire, precisare meriti e confessare difetti. Se la poesia fosse davvero lo scarto dalla norma, sarebbe anche antropologicamente incomprensibile. Nessuno, fra Omero e i suoi ascoltatori greci, aveva l’impressione di assistere a un’infrazione. La poesia invece, e Heaney ne è l’esempio fra i più lampanti, è proprio la norma, che forse abbiamo collettivamente dimenticato e che riaffiora in continuazione e, diciamo così, per sistema nella produzione in versi. È la norma che prevede la lingua come scansione, controllo ed evocazione simbolica dell’assente, come riproduzione e imitazione affettuosa, compartecipe, dei nostri incontri e attriti, che avvengono nel tempo e nel ritmo. È l’unico modo di spiegarsi il grande successo di un poeta come Seamus Heaney. Un vasto pubblico ha visto in lui l’accettata autenticità di una relazione, la sincerità di un’imitazione sentimentale del mondo, l’accesso soggettivo alla vita di tutti.
Accesso soggettivo, e non soggettivistico. Altro miracolo quotidiano di Heaney è stato quello di non sfigurarsi nella maschera del poeta desolato e moderno a tutti i costi. Ci hanno insegnato che la “crisi” è la nostra condizione, attribuendo alla parola un significato al tempo stesso ordinario, onnicomprensivo e metafisico. Quanti poeti accuratamente cittadini, alienati, inabissati! Quanti poeti prosastici e inalberatamente derelitti! Sono i poeti che, spesso ma non sempre in buona fede, hanno accompagnato la reificazione dei rapporti e dei luoghi mettendo la propria lingua in coda a essa, e smettendo di comporre poesie come fossero vere esperienze. L’alterità di Heaney, allora, è stata ancora una volta quella di chi non si apposta nei margini assegnatigli dal mondo moderno, ma usa la poesia per costruire integralmente il proprio tempo con i materiali presenti e passati, rigato dal dolore e ferito dal lavoro. Il mondo non lo ha fatto rimbalzare indietro nel solipsismo, ma gli ha dato sponde e passaggi, tradimenti e glorie.
Nel corso di questa lettura, ho operato diversi accostamenti: Heaney e Yeats, Heaney e Virgilio, Heaney e Dante, Heaney e la poesia medioevale irlandese, Heaney e Thomas. Ma, prima di finire, vorrei metterlo a confronto con un altro dominatore dell’immaginario poetico anglosassone degli ultimi cinquant’anni, ovvero il suo amico Ted Hughes. In Stepping Stones, il nome di Hughes appare decine di volte; Lupercal, del 1960, è uno dei libri che hanno posto il giovanissimo Heaney sulle tracce di sé stesso; divenuti amici nel corso degli anni ’70, i due poeti hanno allestito insieme due antologie poetiche; come abbiamo visto, Heaney ha centrato su Hughes parte del saggio Englands of the Mind; il 3 novembre 1998, al suo funerale, Heaney ha letto due sue splendide poesie, Go Fishing e The Day He Died; gli ha dedicato versi in Electric Light e District and Circle, oltre all’intera versione del Beowulf.
Proprio il Beowulf mi ricorda che – quando è entrato con la propria chiave in casa di Hughes, traducendo il corrusco poema anglosassone – Heaney ha avuto uno straordinario successo di vendite e di critica. Dietro a una serie vistosa di tangenze, il poeta del West Yorkshire e quello della contea di Derry rappresentano ancora oggi due opzioni diverse, due differenti possibilità. Per Hughes, scrivere una poesia è fare una battuta di caccia o di pesca nei fiumi sempiterni dell’anima naturale. Anche stilisticamente, Hughes ha l’iperconnettività accesa e barocca di chi depersonalizza, scioglie, denuncia ogni confine al tribunale dell’anima mundi. Heaney, invece, fin dalla prima raccolta di versi muore come naturalista per il ribrezzo provato nei confronti delle rane. Ha bisogno di una distanza spazio-temporale per trovare la propria vena, una “distanza-Virgilio”, direi. La sua poesia è più autocentrata, si ritrova sempre più nei miti classici. Sontuoso e selvaggio, Hughes canta l’animalità arcaica e impenetrabile all’Io razionale, Heaney canta il lavoro e lo strumento umano. Se Hughes fa poesie immediatamente epifaniche – Nicola Gardini le ha chiamate performances –, grembi gravidi di timor panico, di regressioni e riassorbimenti in un Tutto minuzioso e vorace, Heaney intende la poesia come un mezzo per avvicinare le sponde, per trasformare lo iato in dittongo. Hughes è per una poesia magica, che fa ciò che è, non tanto contatto, quanto dissoluzione della sacca epidermica che ci finge individui. Heaney è meno indiscriminato, non sprofonda, ma si apposta come una vedetta la cui memoria s’impregna, certo, ma poi distingue e sceglie note scandite e trasmissibili. Voltando le spalle alle rane, Heaney instaura la distanza che vorrà poi riparare, grato a un sistema di segni che permette di “vedere cose” e di dirle onestamente presenti e perdute al tempo stesso.
Hughes vuole smolecolizzarsi nel muschio, tornare nel lupo e nel toro, essere identico al guizzo moribondo del luccio, negando la nostra evoluzione, o piuttosto involuzione. Le sue poesie sembrano voler colmare abissi inesauribili, con dei nomi sciamanicamente smisurati nella percussione tribale dello sprung rhythm, del verso accentuativo. Lo stesso riemergere, per lui, è erompere, eruttare. Per Heaney la misura è tutto: se si perde negli occhi acquosi della vicina cieca è per vedere più “distintamente strano”. Ciò che conta è la musica del pianoforte, il passare del treno, il cucire tessuti, arare il terreno, giocare a memoria in un campo dato: arti umane, fantasie strumentali, ergonomiche, che svariano con naturalezza sul tradizionale pentametro giambico. […]
In Hughes, fatalmente, il panismo rischia di diventare estetismo, l’esser gravido può diventare ipertrofia, il regresso può sfociare in voluttà illimitata e contemplazione della morte. Heaney non prevarica, cerca il colloquio, vi reagisce: è più per l’esistenza, come Hughes per l’essenza.
Desidero terminare queste note riportando per intero la poesia St. Kevin and the Blackbird, cui ho già alluso. Incontrai per la prima volta la poesia di Heaney grazie alle traduzioni di Franco Buffoni, all’inizio degli anni Novanta; eppure ritengo che la mia vera iniziazione al suo mondo risalga alla lettura di quei versi. La stretta cella del santo, “pozzo” o cavità/orecchio, listening post; le mani nella direzione l’una opposta all’altra, nella massima apertura; l’accoglimento di ciò che capita e trova in te ciò che di te non sapevi; il nido, la capacità di attesa che credevi fosse “solo” preghiera; l’intorpidimento che diventa più acuta devozione; l’alternativa (o la concomitanza) di agonia e scomparsa, di tensione stordente e amoroso riassorbirsi in strumento di vita: ecco ciò che questa poesia racconta, come in una sintesi di quanto ho tentato di esprimere.
E poi c’era San Kevin e il merlo.
Il santo è in ginocchio, a braccia spalancate, dentro
la propria cella, ma la cella è stretta, dunque
una mano rivolta all’insù, fuori dalla finestra, rigido
come un architrave, quando un merlo vi atterra
e vi si stende, e si dispone al nido.
Kevin sente le uova calde, il piccolo petto, la bella
testa piegata e le zampe e, trovandosi preso
nella rete grande dell’eterna vita,
è mosso a pietà: ora deve tenere la sua mano
come un ramo, al sole e alla pioggia per settimane
finché i piccoli siano schiusi, impiumati e volastri.
*
Ma dato che questa è comunque un’immagine,
immagina d’essere Kevin. E in quale condizione?
Di sé dimentico o in continua agonia
dal collo in giù, fino ai dolenti avambracci?
Ha torpide le dita? Sente ancora i ginocchi?
O che cieche e sotterranee cavità
furtive risalgono in lui? Lontana è, ormai, la sua mente?
Solo e specchiatosi nel gran fiume dell’amore,
“Ora et labora sine mercede,” mormora,
preghiera che compie col corpo intero
poiché ha scordato sé stesso, scordato il merlo
e sul filo del fiume del fiume ogni nome.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).