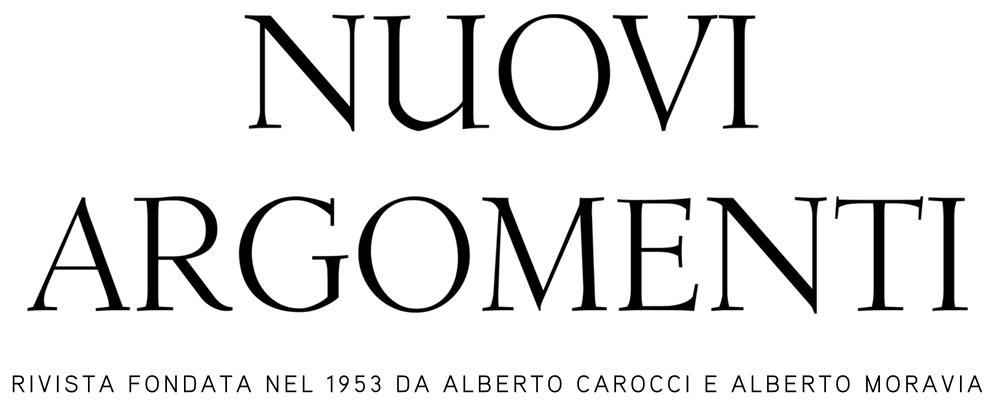Potenza e privazione
agli amici Alberto Puoti e Daniele Baglioni.
1.
È del tutto simile ad un avvitamento,
a quella proiezione dell’avvitamento
cromosomico x ed y,
ma tutto spostato verso il basso,
verso quella fessura profonda nella massa.
Ma quale confusione di oggetti
si nasconde lì dentro?
nella mente che non vuole farsi scoperta
ma avvitamento autoreferenziale, almeno
nel mio sfortunato caso.
1.1
Dunque, data simile premessa, suppongo,
di non restare che paralizzato, convivendo
con questo paradosso psichico,
dove l’atto che si possa attuare non si genera,
ma tutto è negazione o assenza
o privazione di movimento.
1.2
Quale peggiore condanna di questa:
che l’idea generata dalla mente
nel momento stesso in cui viene, come un siero,
messa in circolo, pronta poi a farsi atto o azione,
non viva che nella mente, non si nutre
che del pensiero. E questo le basta.
1.3
Quale vita vado implorando?
quale via di fuga? quale potenza o possibilità sarebbe la mia,
se la potenza non esisterebbe che nell’atto?
2
Seduto nel mio studio,
circondato da oggetto immobili,
l’orecchio, ad oggi, sembra
l’unico organo tornato vivo dal letargo.
2.1
Del resto non esisto che del mio pensiero,
in questo fittizio contatto con le cose
che ho intorno. Che loro, le cose, non possono
corrispondere che alla realtà di fuori.
2.2
«Alla ragione non interessa altra vivanda
che lo strazio del pensiero»,
e lo strazio fu che grandezza o miseria dell’uomo
fu innanzitutto privazione o possibilità di non-non passare all’atto.
2.3
Ma se è nella non potenza
che la potenza dovrebbe misurare la sua grandezza,
ecco quindi spiegato perché l’esistenza
si mostrerebbe in quel momento più vera,
perché in quello e in questo
la mente non riesce a collocarmi, a farmi esistere?
2.4
Ragionavano di un astuto accerchiamento
di un lento mutare del tono, simile ad un rompete le righe,
mentre la parola mi prendeva forma nella mente.
Senso del cristianesimo
3
Un viso altro,
ma distante dalla raffigurazione reale di un viso,
ma più caritatevole.
Perché non preghi? perché non supplichi
che qualcuno ora t’ascolti? lì dove te impedisce a te
di udire, di vedere una speranza per la moltitudine di fuori?
Dovremmo farti un segno,
rivelare tutta questa volubilità,
che poi è egualmente la volubilità del creatore,
perché dall’uno l’altro non può prescindere,
diventare io e uno, negare quel difetto
originario, inghiottire
in questa moltitudine.
3.1
E questo fu l’incantamento della moltitudine:
fu credere ciò che non può esistere che per solo atto,
fu questa misericordia del silenzio,
questi atti che vorrebbero rappresentare
qualcuno o qualcosa,
ma come fu possibile rappresentarlo,
l’atto malcerto o l’atto originario,
ancora la moltitudine lo ignora.
3.2
Subito, amici, bisogna farlo subito
il conto elementare dello scopo, l’elemento fatto
rappresentazione,
di cosa ti lamenti allora? a cosa cerchi di aggrapparti?
te che sempre retrocedi lontano dall’atto decisivo.
3.3
La verità, in conclusione, tenderebbe verso l’alto
e non ne esisterebbe che una:
tuttavia solo il metodo fu a salvarmi,
se fui poi salvo, nell’interpretazione dell’esempio.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).