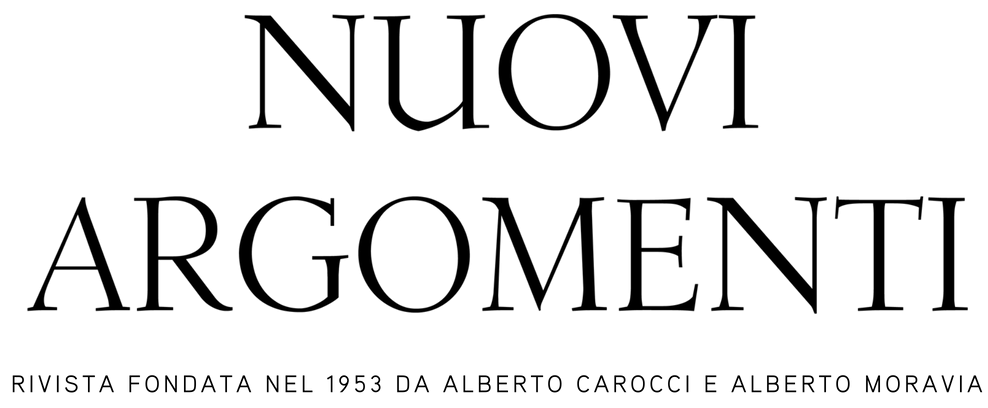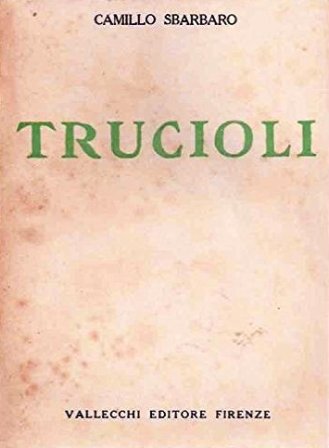non so perché, ho sempre sperato poco dalla poesia, l’ho sempre considerata per un intermezzo, un episodio. Sento che mi abbandonerà, ma non solo: mi lascerà nelle braccia della prosa, nella quale spero molto di più[1].
Questa dichiarazione, risalente agli anni di Pianissimo, getta implicitamente luce su un aspetto dell’opera di Sbarbaro – l’esigua produzione lirica – che rientra tra i fattori all’origine di un certo atteggiamento pregiudiziale per cui, fin dai banchi di liceo, ci si accosta a tale opera come a quella di un poeta «minore». È la sorte toccata a molti poeti che hanno lasciato pochi versi, anche se il caso del ligure, un autore peraltro avvezzo alle etichette (su tutte quella assolutamente falsa di «vociano»), è del tutto particolare: l’assunto per cui egli «ha scritto poco» vale, infatti, se riferito a Sbarbaro poeta, non a Sbarbaro scrittore. Spieghiamo questa affermazione partendo da una breve rassegna delle sillogi pubblicate.
Sbarbaro è un poeta «magro», dove al significato che Tomasi di Lampedusa dà al termine si lega quello di «poco prolifico». Le raccolte edite sono cinque: oltre al capolavoro Pianissimo, uscito per «La Voce» nel 1914, troviamo il giovanile Resine, edito nel 1911 su iniziativa degli ex compagni di liceo, e altri tre volumetti usciti a distanza di molto tempo dai primi due: Rimanenze (1955), Versi a Dina (1956) e Primizie (1958). Guardando, invece, a Sbarbaro scrittore, ovvero al complesso della sua opera, è evidente come egli non sia affatto un autore poco prolifico. Nella dichiarazione posta in apertura di questo saggio egli di fatto anticipa ciò che possiamo osservare ora nella sua bibliografia: la poesia non è che un «episodio» all’interno di un’opera nettamente segnata da ciò in cui Sbarbaro «sperava molto di più», la prosa. Nutritissimo, infatti, il corpus: Trucioli (1920), Liquidazione (1928), Fuochi fatui (1956), Scampoli (1960), Gocce (1963), Contagocce (1965), Bolle di sapone (1966), Quisquilie (1967), a cui si deve aggiungere la prosa scientifica degli studi lichenologici, quella delle numerose traduzioni dai romanzieri francesi e quella del ricchissimo epistolario.
Ora, chiarito che l’opera sbarbariana è ampia e connotata soprattutto dalla prosa, torniamo alle parole iniziali. Sbarbaro le scrive in un momento cruciale, ossia durante la composizione dei testi di Pianissimo, il libro che lo consacrerà come poeta. Mentre stanno nascendo i frutti più maturi della sua poesia, cioè, l’autore rivela di considerare la scrittura in versi soltanto un «episodio» all’interno della propria attività di scrittore, un momento che, come tale, conoscerà una fine. E la fine verrà di lì a poco, una volta che Pianissimo avrà visto la luce: la scrittura in prosa fiorisce, infatti, proprio dopo il 1914, l’anno di pubblicazione di quello che sostanzialmente costituisce non solo il suo libro d’esordio ma anche quello conclusivo. In effetti, le raccolte che vedono la luce dopo Pianissimo sono frutto di una scrittura ormai divenuta sporadica e poco ispirata rispetto a quella dei primi anni Dieci, e tutte e tre vengono significativamente pubblicate con clamoroso ritardo rispetto all’epoca della loro composizione: Rimanenze del 1955 risale al 1921, i Versi a Dina, in volume nel 1956, erano già usciti in rivista nel 1931, mentre Primizie del 1958 contiene addirittura testi precedenti a Pianissimo. L’unico progetto lirico in cui Sbarbaro riversa con zelo le proprie energie dopo il 1914 è rappresentato dall’infelice riscrittura di Pianissimo del 1954.
Pianissimo, quindi, rappresenta a tutti gli effetti quell’«episodio», ed è evidente che Sbarbaro, proprio mentre sta componendo la silloge, sappia già che essa racchiuderà l’intera sua esperienza di poeta: egli ha già decretato la fine di quell’«episodio» e intravede l’inizio della nuova esperienza in prosa.
Quali sono le ragioni di questa rinuncia? E perché, proprio mentre la sua voce lirica sta trovando massima espressione nei testi di Pianissimo, Sbarbaro ha già deciso di approdare al silenzio della prosa? Certamente un fattore è rappresentato dal costante atteggiamento di indifferenza e disinteresse nei confronti dei propri versi, rimarcato nei titoli scelti per le sillogi che ne sottolineano l’inconsistenza e la casualità. Tuttavia, è soprattutto il periodo in cui quella dichiarazione è stata scritta a racchiudere il senso dell’abbandono della poesia da parte di Sbarbaro. Attraverso la scrittura di Pianissimo, una raccolta che in origine egli intitola significativamente Sottovoce, Sbarbaro comprende che la propria voce poetica, già debole dal principio, sta via via affievolendosi e trasformandosi in una non-voce, in silenzio, in prosa. Le ragioni ideologiche alla base del cambio di rotta operato da Sbarbaro dopo Pianissimo non possono che essere ricercate, quindi, in quell’opera che è anzitutto un’indagine sulla possibilità della parola di «dire» e dove la parola, proprio perché pronunciata «pianissimo», rivela il senso della sua origine e della sua fine.
«Voce» e «silenzio» non costituiscono soltanto le due strade al crocevia delle quali sorge la particolare parola di questo libro, ma si configurano come veri e propri oggetti d’indagine all’interno di esso. Pianissimo[2] si apre, infatti, all’insegna del silenzio: «Taci, anima stanca di godere | e di soffrire» (I, 1, vv. 1-2). «Taci», come nel primo testo della seconda sezione (Taci, anima mia. Son questi i tristi), non è un’esortazione, ma la constatazione del silenzio dell’«anima» del poeta, un’anima che non gode più e non soffre più, dove ogni residuo di vita tace. L’anima è diventata «ammutolita» e questo silenzio è un vuoto di disperazione rassegnata. Di fronte ad esso l’evento della morte risulterebbe un’ovvia conseguenza («Noi non ci stupiremmo non è vero, mia anima, se il cuore | si fermasse, sospeso se ci fosse | il fiato…», vv. 11-14), anzi, rappresenterebbe una salvezza, nella quale però il poeta non può sperare. Una condizione ben più traumatica lo aspetta, quella del sonnambulismo, di chi continua a vivere senza rendersene conto: «Invece camminiamo. | Camminiamo io e te [anima] come sonnambuli» (vv. 15-16). Ogni residuo di vita è scomparso: «La vicenda di gioja e di dolore | non ci tocca» (vv. 21-22), regna l’apatia, il silenzio. Le cose hanno perso la capacità di parlare, hanno perso quell’incanto che permetteva ancora una comunicazione tra uomo e mondo: «Perduta ha la sua voce | la sirena del mondo» (vv. 22-23), la realtà è divenuta afona, priva di voce, cioè priva del più evidente segno di vita. Per questo il mondo è diventato «un grande deserto»: il deserto è il luogo dell’assenza di vita (e di voce) per eccellenza. Tuttavia, il silenzio non rappresenta soltanto la perdita dell’incanto del mondo o l’apatia in cui è caduta l’anima del poeta, ma in Pianissimo diventa strumento di conoscenza, è ciò che permette di svelare epifanicamente la verità, contro l’inganno creato dai rumori della «consuetudine»:
……………..Tace intorno
la casa come vuota e laggiù brilla
silenzioso coi suoi lumi un porto.
Ma sì freddi e remoti son quei lumi
e sì grande è il silenzio nella casa
che mi levo sui gomiti in ascolto.
Improvviso terrore mi sospende
il fiato e allarga nella notte gli occhi.
(I, 3, vv. 3-10)
Il silenzio smaschera la realtà, permette l’improvvisa presa di coscienza da parte di Sbarbaro che la propria vita è «separata dal resto della terra», di essere «solo al mondo» (v. 13), porta cioè alla scoperta di ciò che il «sonno», la vita apparente e consueta, non fa né vedere né ascoltare. Solo il «mondo muto delle cose» (v. 27) impedisce al poeta di sentirsi solo, proprio quelle cose che comunicano tacendo e non riempiono di parole il mondo. L’inadeguatezza della parola viene espressa in maniera inequivocabile nella dodicesima lirica della prima sezione, I miei occhi implacabili che sono: «Col rumor della voce noi vogliamo | creare fra di noi quel che non è» (I, 12, vv. 7-8); soltanto il silenzio può rivelare la verità, il tentativo fallito di una comunicazione impossibile: «quando taciamo non sappiam che dirci | ed apre degli abissi quel silenzio» (vv. 9-10). Il «rumore della voce» risulta un segno di quella vita regolata dalla «consuetudine» che Sbarbaro non può accettare, perché falsa e apparente: «Ogni voce m’importuna» (I, 16, v. 7); ne consegue l’amore per il «mondo muto delle cose», per la «voce delle cose» inanimate, le più simili al soggetto estraniato.
Il silenzio rappresenta l’ultimo baluardo per un’indagine sull’esistenza di un soggetto svuotato delle possibilità conoscitive e incapace di porsi come centro di verifica dell’esperienza. Pianissimo si configura, così, non soltanto come percorso di indagine su se stesso, bensì è per Sbarbaro anche un’analisi sulla possibilità della parola di «dire». L’ultima tappa di questo percorso è la conclusione di questa duplice indagine:
Ma poi che sento l’anima aderire
ad ogni pietra della città sorda
com’albero con tutte le radici,
sorrido a me indicibilmente e come
per uno sforzo d’ali i gomiti alzo…
(II, 10, vv. 11-15)
Nel «sorrido a me indicibilmente» dell’ultima lirica del libro c’è tutta la rassegnazione del soggetto che, arrivato alla fine del percorso di autoscopia, constata la propria reificazione e di conseguenza, in quanto divenuto «cosa», l’espropriazione di ciò che definisce l’uomo in quanto tale, la parola. Sbarbaro accetta tutto questo e lo fa senza aggiungere parole, ma con un sorriso, un sorriso «indicibile».
A questo punto, di fronte all’inefficacia della parola quale valore ha la poesia? Se l’io si mostra insufficiente come termine di verifica dell’esperienza, se riesce a coglierla soltanto rinunciando al segno distintivo dell’essere umano, la parola poetica non può portare significati che suggeriscano qualcosa al di là dell’apparenza, ma soltanto registrare la grande tautologia dell’esistenza, per cui «tutto è quello | che è, soltanto quel che è». Ma allora che senso ha, per Sbarbaro, scrivere? A maggior ragione viene da chiederselo leggendo uno dei suoi Trucioli:
Da quando posso parlare, la mia vita è colpita da immobilità.
Del più desiderabile bene, se la parola lo tocca, rimane la buccia. […] Così da me mi muro e pietre sono le parole. […] Ma forse in fondo a questa strada è il silenzio. Già ogni parola m’è di troppo. Presto riempirò la pagina con una interiezione. […] Diventi muto e le parole non dette mi restino pietre sul cuore, purché parta un giorno pel mondo a scordarmi anche il nome[3].
Le parole non soltanto sono inefficaci nel veicolare significati, ma rappresentano un muro di pietre che si erge attorno all’autore. L’uso delle parole crea immobilità, per questo Sbarbaro sogna di limitare la scrittura ad una sola interiezione, aspira al silenzio, a diventare muto. La vita diventa immobile perché il poeta la vive in anticipo nella scrittura: «E quando potei pregare: Padre, che ci hai tenuto sui ginocchi…, in quel punto mio padre morì (la sua morte naturale fu un bis increscioso)»[4]. In questo senso è come se Sbarbaro si murasse vivo entro le proprie parole e non riuscisse a scavalcare quel muro, cioè a vivere con autenticità: il vivibile è già stato vissuto nella scrittura. Il desiderio di diventare muto è il desiderio di evitare le parole, cioè di anticipare nella scrittura la vita. Sbarbaro, però, scrive. Seppur inadeguato, inefficace, muro in pietra insormontabile che corrisponde a un blocco vitale, la parola rappresenta per Sbarbaro l’unica felicità, come afferma in un testo presente in Versi a Dina: «Non abbiamo | altra felicità che di parole»[5]. La contraddizione è evidente. Non è certo l’unica in questo autore, ma se di solito in Sbarbaro le contraddizioni non si risolvono, qui forse si giunge a un compromesso. Il poeta sa che la parola può soltanto registrare l’aspetto tautologico del mondo ed è inadeguata a veicolare il senso, ma sa anche che tale inadeguatezza deriva dall’insufficienza dell’uomo di fronte al manifestarsi della verità. Per questa ragione, tra il silenzio e la parola che rispecchia il suo essere insufficiente, Sbarbaro decide di imboccare non la prima strada, quella del silenzio poetico, ma con Pianissimo arriva ad un compromesso: sceglie una parola che stia a metà tra il silenzio e la propria voce, una parola che porta «le stimmate della propria genesi dolorosa e necessaria», come già notava Montale[6], una parola pronunciata «a fior di labbro»[7], «sottovoce», «pianissimo».
A un certo punto, tuttavia, questa parola azzerata non è più sufficiente. Si tratta di una soluzione temporanea, di cui Sbarbaro è ben consapevole già durante la composizione del suo capolavoro, come si evince dalla dichiarazione da cui siamo partiti. L’approdo alla «terraferma» della prosa è la logica conseguenza di quel tentativo rappresentato da Pianissimo, l’esito naturale di una parola pronunciata «sottovoce»: esso diventa necessario allorché Sbarbaro si rende conto che «dire io» non può che risolversi in un dire «pianissimo» proprio a causa dell’inconsistenza di quell’io. La scelta della prosa, del frammento, fino ad arrivare all’aforisma, è inevitabile in quanto unica forma espressiva disponibile di fronte alla crisi di un soggetto che non riesce più ad essere centro unificante dell’Erlebnis. Di fronte alla disgregazione di un mondo reificato, privo di valore universale, Sbarbaro non può che raccontare la realtà, a sua volta disgregata, della propria esistenza, ma soltanto il silenzio della prosa, e non la voce della poesia o il compromesso di una parola pronunciata «pianissimo», è in grado di sorreggere la conclusione a cui egli è arrivato, quella di esser divenuto egli stesso una cosa, un oggetto del mondo, un frammento.
[1] C. Sbarbaro, Cartoline in franchigia, in Id., L’opera in versi e in prosa, a cura di G. Lagorio e V. Scheiwiller, Milano, Garzanti, 1999, pp. 553-554.
[2] Per Pianissimo, l’edizione di riferimento, da cui provengono le citazioni, è quella curata da L. Polato, che riporta la redazione originaria del 1914, C. Sbarbaro, Pianissimo, a cura di L. Polato, Venezia, Marsilio, 2001.
[3] Sbarbaro, L’opera in versi e in prosa, cit., p. 133.
[4] Ibidem.
[5] La bambina che va sotto gli alberi, in Versi a Dina, ivi, p. 114
[6] E. Montale, prefazione a C. Sbarbaro, Poesia e Prosa, a cura di V. Scheiwiller, Milano, Mondadori, 1979, p. XI.
[7] «[…] una notte che coi sensi giacevo a letto “lungo disteso come in una bara”, mi venne da sé alle labbra la constatazione: Taci, anima stanca di godere e di soffrire… Prendevo coscienza di me; nasceva il mio secondo libretto di versi: una specie di sconsolata confessione fatta a fior di labbro a me stesso». Sbarbaro, L’opera in versi e in prosa, cit., pp. 472-473.
Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).