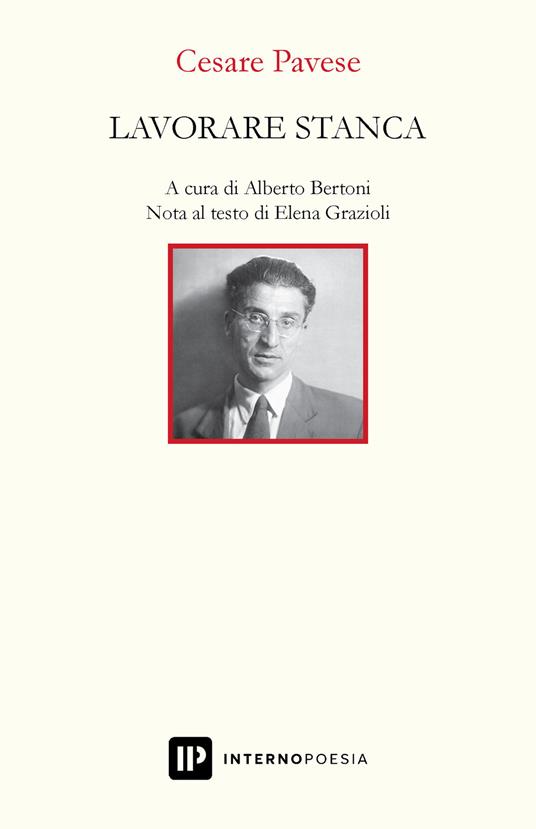In occasione della riedizione di “Lavorare stanca” di Cesare Pavese, a cura di Alberto Bertoni, con nota al testo di Elena Grazioli, in uscita per Interno Poesia, pubblichiamo in anteprima la prima parte del saggio introduttivo.
Solo da non molto tempo, sulla scia di un interesse rinnovato per l’avventura umana e per l’opera letteraria di Cesare Pavese, si comincia a inquadrare con attenzione più convinta Lavorare stanca, la sua opera prima, che è anche un’opera di poesia. Tale attenzione coinvolge tanto il quadro storico del decennio nel quale il libro è stato concepito e scritto (gli anni fra il 1930 e il 1940) quanto la sua originalità tematico-formale e la fisionomia delle sue due stampe, che uscirono rispettivamente nel 1936 per le edizioni di “Solaria”; e nel 1943 per Einaudi, di cui l’autore era anche coordinatore (e poi, dal ’47, direttore) editoriale. La prima conclusione di questi esercizi di rilettura, sempre più frequenti almeno a partire dal 1998 dell’edizione Guglielminetti-Masoero (peraltro comprensiva di tutte le poesie di Pavese)[1], riconosce in Lavorare stanca un ruolo di unicum sia nella bibliografia pavesiana sia nello svolgimento novecentesco della poesia italiana ed europea.
Non è stato sempre così, poiché il libro d’esordio di Pavese nel corso della sua storia critica è stato talora collocato in secondo piano, quando non in qualche caso liquidato come un testo irto di -ismi negativi: tanto da coinvolgere in un giudizio fortemente limitativo anche i due massimi critici formali della nostra poesia contemporanea, Gianfranco Contini (“quasi opera populista d’un solipsista”[2]) e Pier Vincenzo Mengaldo, che s’industria a definirlo un tentativo incapace di nascondere “tutto il suo carattere programmatico e meccanico, che dalla forma si ribalta sullo stesso contenuto ideologico con cui fa corpo”, in nome di un “narcisismo ed egotismo insopportabilmente truccati di populismo”[3].
A rileggerlo oggi, invece, Lavorare stanca si raccomanda come un’opera positivamente innovativa e tutt’altro che inattuale tanto sul piano metrico-linguistico quanto nelle sfere topica, antropologica e comparatistica. La ragione prima di tale vitalità risiede nella sua capacità di oggettivazione dei punti di vista, che in certi passaggi si dispiega al modo di uno Spoon River trasposto in Piemonte tra persone vive e che comunque non è lecito identificare nella celebrazione di un io lirico, bensì – semmai – nell’affresco a dominante narrativa di una comunità di umili, in movimento fra le Langhe (dove Pavese era nato nel 1908) e Torino. È molto difficile, infatti, isolarne una sola poesia in cui l’io narrante possa venir riconosciuto con certezza in quello della persona biografica di Cesare Pavese, oltre al fatto che di narcisismo, nelle figure umane da cui il libro è popolato, è quasi impossibile trovare traccia.
Perciò, se si vuol racchiudere Lavorare stanca in una formula, la migliore rimane quella di “sperimentalismo realistico”, forgiata per le “poesie-racconto” che lo compongono da Edoardo Sanguineti, il quale le stimava proprio per la loro capacità di resistenza al “trionfo, tutto novecentesco, della poesia come lirica.”[4] A ciò si aggiunga un impianto lessicale che fa interagire il realismo “lessicalmente ripulito” di un “dizionario di base, tutto sommato quasi petrarchesco”[5] (cui però fanno ostacolo non poche eccezioni, se è vero che la matrice di tale monolingua in Italia è generalmente neoclassica) con l’adesione a un parlato venato ma non sopraffatto da inflessioni dialettali e gergali piemontesi, irradiate dal lessico alla sintassi, fino a coinvolgere la retorica complessiva dei testi. A ciò si aggiunge una dialogicità per così dire naturale, tra monologo interiore e discorso diretto, che rimanda al modello lasciato in eredità dal Gozzano dei Colloqui: un modello ancora abbastanza prossimo e disteso anch’esso fra Torino e immediati dintorni “collinari”, con le Langhe al posto del Canavese. In ogni caso, l’incontestata novità metrica di Lavorare stanca diviene l’elemento regolatore di un discorso che intraprende un “cammino verso la lingua comune” e che – ad ascoltare l’autorevolissimo Coletti – si avvale di “sintassi del parlato, prosasticità, lessico quotidiano, dialettalismi: tutto questo per avvalorare la ciclicità fabulatrice, la riproducibilità delle storie, la fungibilità dei testi.”[6]
Sull’asse formale, per l’appunto, questo Pavese ventottenne concentra nella prova d’esordio – con piena consapevolezza – una metrica e una prosodia estranee ed anzi contrapposte alla koinè dei nostri anni Trenta. Il verso libero di Lavorare stanca, se è lecito chiamarlo così una volta che si siano constatati anisosillabismo e anisostrofismo come suoi elementi costitutivi, rifiuta la matrice francese e simbolista del vers libre liricamente e comunemente inteso: e quindi evita di aderire a quella libertà melodica, veggente e danzante, intessuta di liquide suggestioni e di evocazioni multisensoriali, fra canto, pulsione inesausta alla musicalità se non alla musica e delibazione estetizzante dell’antico, che è radicata nelle poetiche del Simbolismo internazionale, alla ricerca anche teorica di quell’anima delle cose che ovunque poteva collocarsi, purché al di fuori del mondo. C’è subito da annotare, tuttavia, che Pavese rimaneva estraneo anche alla ricerca cronologicamente ed editorialmente contigua di Montale, così come veniva definendosi in chiave di correlazione oggettiva a partire dalle Occasioni, Einaudi 1939 e successive, ravvicinate edizioni, in sostanziale coincidenza con la “nuova edizione accresciuta” di Lavorare stanca.
Infervorato dalla tesi di laurea dedicata a Walt Whitman[7], Pavese compie una scelta preliminare a favore di una tradizione metrico-prosodica in Italia laterale, perché niente affatto endecasillabica e in parallelo disinteressata ad affondare i suoi gangli vitali nelle sperimentazioni “barbare” o nel poème en prose simbolista. No, gli ascendenti di Lavorare stanca vanno riconosciuti piuttosto nei Semiritmi di Capuana; in Thovez; in vociani quali Rebora, Boine e soprattutto Jahier per la sfida perenne che egli produce tra verso e prosa; ma in primis nel Bacchelli dei Poemi lirici (1914). Forse perché destinato anche lui a un futuro di narratore, il Bacchelli degli anni Dieci si impegnò a modulare la propria poesia su una misura di quattro tempi forti, votata all’uso per antonomasia poetico e solo in apparenza contraddittorio dell’enjambement nonché mèmore dell’eco dei versetti biblici, come fu proprio di Walt Whitman: il Whitman cantore dell’epopea statunitense di frontiera attraverso quella “Bibbia democratica” che coincideva con l’archetipo di Foglie d’erba (edito lungo un considerevole arco di tempo, fra 1855 e 1892).
Pavese aderisce a questa medesima tipologia metrica, dopo aver portato a termine un cospicuo apprendistato, che trova felicissimo compimento nell’incipitaria I mari del Sud (1930), aperta fra l’altro da una frugale dedica (“a Monti”) al proprio professore di liceo, colui che lo avrebbe messo in contatto con l’altro suo allievo Giulio Einaudi. Nella metrica di Whitman, introdotta nel mondo francese da Paul Claudel, Pavese riconosce d’acchito una potenzialità narrativa (inclusiva della prosa del mondo), invece che meramente lirica e soggettiva: un apparato intonativo, per l’appunto, che predilige – pur sempre entro la gamma di virtualità “orali” consentite dalla lingua italiana – un verso non più sillabico-accentuativo ma fondato su quattro (e talora anche su cinque o più di rado sei) tempi accentuali forti che – derivando appunto da Whitman e dalla sua sensibilità ritmica tutta americana – demolisce il mito della nostra tradizione endecasillabica. Ed è un verso che si fonda su una somma di piedi anapestici (breve breve lunga, cioè atona atona tonica) che – in qualche caso, ma non sempre – si conclude in un doppio settenario, edificando una costellazione di ipometrie da sinalefe, che abbastanza di frequente sfocia nel tredecasillabo: es. “Tanti corpi di donna han varcato nel sole” oppure – regolarmente alessandrino – “la compagna uscirà per le strade, leggera”.
In proposito, però, conviene una precisione ancor più inattaccabile, ricorrendo all’esatto ed esaustivo scrutinio descrittivo, con il suo sovrappiù di esemplificazioni pratiche, già compiuto quasi mezzo secolo fa da Costanzo Di Girolamo: “Il verso di Pavese non ha misura fissa, e può variare da un minimo di dodici, a un massimo di diciotto posizioni, seguite generalmente dalla sillaba atona finale. Ciò che rimane invece costante, indipendentemente dal numero delle posizioni, è il preciso ritmo del verso, ‘ternario’ o, come mi sembra preferibile, ‘anapestico’: con l’avvertenza che una semiforte è sempre presente in prima posizione, mentre tutti gli ictus interni sono primari. Ne risulta una sequenza di quattro o cinque o anche sei piedi (ascendenti, se si considerano solo le forti) di tre elementi, più l’atona conclusiva:
tetrapodia (12 posizioni):
+ – + – – + – – + – – + (s)
Parla il giovane smilzo che è stato a Torino. (Terre bruciate, v. 1);
pentapodia (15 posizioni):
+ – + – – + – – + – – + – – + (s)
Sento il mare che batte e ribatte spossato alla riva. (Terre bruciate, v. 13);
esapodia (18 posizioni):
+ – + – – + – – + – – + – – + – – + (s)
e berrà del suo vino, torchiato le sere d’autunno in cantina. (Atlantic Oil, v. 32).”[8]
Solo in apparenza un simile meccanismo poteva suonare monotono, poiché affidava la propria effettiva varietà al montaggio delle diverse sequenze (non solo sonore ma anche visive, in senso cinematografico) lungo il doppio binario della compattezza e della durata “orizzontali” del singolo verso scandito in anapesti, non di rado separati da cesura, che dovevano venir posti in rapporto da un lato con il montaggio degli altri versi precedenti e successivi, prosodicamente tutt’altro che identici; e dall’altro con l’incrocio dinamico e insieme spesso contrastivo del ritmo poetico e della sequenza sintattica, discorsiva e narrativa, cui corrisponde la relativa e non poco fitta punteggiatura. Si pensi a una sequenza simile: “E si leva la luna. Il marito è disteso/ in un campo, col cranio spaccato dal sole/ – una sposa non può trascinare un cadavere/ come un sacco – . Si leva la luna, che getta un po’ d’ombra/ sotto i rami contorti.” Tutto si potrà affermare, a proposito di questo attacco di seconda strofa di Luna d’agosto, tranne che sia prosodicamente uniforme, sicché Pavese mostra qui di saper spingersi oltre la “splendida monotonia” che pure dichiarava di apprezzare in Whitman come sigla d’identità. Ma d’altra parte l’America per Pavese coincideva anche con l’ammirazione verso un cinema (anche nel suo sottogenere western, per esempio) che era sinonimo dell’arte giovane, antiborghese, estranea agli scenari di cartapesta architettati dal regime fascista e soprattutto orientata a nutrire una figuratività nuova, di cui jazz, “blues e saxs” erano la naturale colonna sonora.
Accogliere nel proprio lavoro poetico l’estetica del cinema, naturalmente, comportava una serie di accorgimenti testuali che non coinvolgevano soltanto il montaggio delle immagini e dei tòpoi, ma che si estendevano anche alla retorica profonda dei testi, per esempio con un evidente prevalere delle figure di sineddoche/metonimia sulla metafora, poiché – almeno in linea di massima – il meccanismo analogico non era particolarmente amato da Pavese. Esempio acclarato di ciò è la magnifica chiusa di Ozio, poesia-racconto della quale è protagonista l’amato personaggio di Masino: “[…] Masino contempla,/ su un paese di nude colline, di prati e di fabbriche,/ la sua testa ingrandita in primissimi piani./ Quelli almeno non dànno la rabbia che dànno i cartelli/ colorati, sugli angoli, e i musi di donna dipinti.”
Di sicuro, insomma, l’istanza verbale profonda di Lavorare stanca non coincide con quella neorealistica di una mimesi fin che si vuole polifonica di un mondo “basso”, ma si distende su una linea intonativa unitaria, attraverso la quale i poemetti narrativo-descrittivi che compongono il libro si articolano per “giustapposizione di blocchi”. E intanto le loro “iterazioni pesanti costruiscono luoghi e persone, rapporti di interesse e di eros, tensioni fra città e campagna; e tutto questo è dominato da un senso di fatalità più che di destino, di attesa passiva, di pianto ringhiottito, di sfinitezza irrimediabile.”[9]
In proposito, a partire da questa falsariga autorevolmente seguita da Franco Fortini, non sarà superfluo aggiungere che, sul versante opposto delle opzioni metrico-formali che si offrivano a un poeta giovane nell’Italia degli anni Trenta, agiva una koinè plasmata e dominata dal gusto ermetico, quasi per antonomasia permeato di gusto analogico. L’ermetismo storico, infatti, era già ben rappresentato – all’altezza cronologica della prima edizione di Lavorare stanca – dagli archetipi dell’Ungaretti di Sentimento del tempo (1933, ma anticipato da quella Difesa dell’endecasillabo che risaliva al ’27), del Quasimodo della produzione che grossomodo trovava il proprio culmine nell’antologia dei Lirici greci (1940) e degli esordi dei giovani fiorentini di cui fu capofila il Mario Luzi autore ventunenne della Barca, nel 1935. Alla poetica dell’ermetismo apparteneva – insieme col mito formale di quello che Attilio Bertolucci avrebbe chiamato “il metronomo dell’endecasillabo” – un afflato mitologico-religioso, la cui tensione al trascendente poggiava su una metaforologia tutt’altro che estranea, nelle evenienze più originali, ai transfert stranianti degli esperimenti surrealisti, con la mediazione spagnola dell’eccezionale “generazione del ’27”, da Garcia Lorca a Machado, a Rafael Alberti. Resta vero però che, nella prassi dell’introduzione scolastica alla poesia, a dispetto del nuovo vegetava in Italia anche un dilettantismo intriso di tardi echi pascoliani e dannunziani, tremendamente indeboliti rispetto agli originali.
A ciò si aggiunga che l’eco metrico-prosodica di Foglie d’erba in Lavorare stanca non coinvolge soltanto – sbriciolandola – la microfisica del computo sillabico, ma certifica piuttosto il ruolo di perno formale che il libro poetico d’esordio di Pavese assume rispetto a una linea temporale piuttosto prolungata, entro la nostra tradizione in versi. Prima di Lucini e di Pascoli, la ricezione metrica di Whitman era stata sancita da uno studioso positivista, Pasquale Jannaccone, che nel 1898, proprio a Torino, aveva pubblicato un libro intitolato La poesia di Walt Whitman e l’evoluzione delle forme ritmiche: un libro di grande acume descrittivo e comparativo[10], nel quale per esempio si riconosce che non nell’iteratività dei piedi anapestici si può riconoscere la novità whitmaniana, bensì nell’architettura musicale del suo costituirsi in discorso. Ed è proprio questa peculiarità ad attrarre e coinvolgere Pavese, se è vero che “la forma poetica di Walt Whitman […] ha in comune con la musica la struttura dei periodi e l’arte dello svolgimento del pensiero”[11].
Al capo opposto di questo fenomeno di vera e propria longue durée formale, si situa il riuso che della struttura metrica di Whitman-Bacchelli-Pavese viene fatto di questi tempi all’interno delle sperimentazioni rap (con Caparezza e Murubutu a incarnare in questa chiave gli autori letterariamente più consapevoli), cui pertiene un’adesione pressoché spontanea a quella che oggi viene chiamata proprio “metrica del discorso” o “metrica semantica”: una metrica resa peculiare dalla “presenza di varie specie di ripetizione e soprattutto di anafora, che in effetti ‘danno forma’ al testo, lo giustificano ritmicamente”[12]. E così non sarà certo difficile, per la sua estensione quantitativa ma soprattutto qualitativa, riconoscere il ruolo strutturale dell’anafora in Lavorare stanca.
Note:
[1] Cfr. C. Pavese, Le poesie, a cura di M. Masoero e con introduzione di M. Guglielminetti, Einaudi, Torino 1998.
[2] G. Contini, Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Sansoni, Firenze 1968, p. 1003.
[3] P.V. Mengaldo, La tradizione del Novecento. Terza serie, Einaudi, Torino 1991, p. 154.
[4] E. Sanguineti (a cura di), Poesia italiana del Novecento, vol. II, p. 1049.
[5] Cfr. T. Scarpa, Come stendersi nudi all’aperto sui versi, introduzione a C. Pavese, Le poesie, Einaudi, Torino 2020, pp. V-XXVI. Qui p. XXIV.
[6] V. Coletti, La diversità di Lavorare stanca, introduzione a C. Pavese, Lavorare stanca, Einaudi, Torino 2001, pp. V-XXIV. Qui p. XI.
[7] Cfr. C. Pavese, Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea, 1930, a cura di Valerio Magrelli, Einaudi, Torino 2006.
[8] C. Di Girolamo, Il verso di Pavese, in Teoria e prassi della versificazione, il Mulino, Bologna 1976, pp. 183-96. Qui p. 185.
[9] F. Fortini, I poeti del Novecento, Laterza, Bari 1988, p. 120.
[10] Cfr. A. Bertoni, Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano, il Mulino, Bologna 1995, in particolare pp. 205-14.
[11] P. Jannaccone, La poesia di Walt Whitman e l’evoluzione delle forme ritmiche, Roux Frassati & C. Editori, Torino 1898, p. 119.
[12] P. Giovannetti-G. Lavezzi, La metrica italiana contemporanea, Carocci, Roma 2010, p. 248.