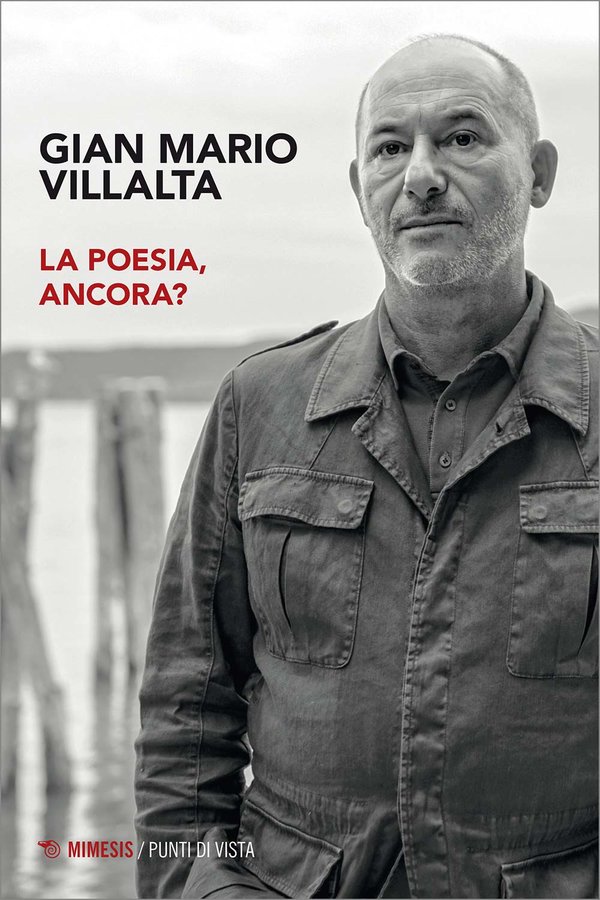“La poesia, ancora?” raccoglie alcuni scritti in prosa di Gian Mario Villalta sulla poesia come genere letterario oggi, sul suo valore come esperienza estetica e di conoscenza, sul suo rapporto con la società. Pubblicato da Mimesis nella collana “Punti di vista. Testi e studi di letteratura italiana contemporanea”, il volume propone riflessioni teoriche e sociologiche di estremo interesse. Presentiamo in anteprima uno dei capitoli.
Esaltare il proprio tempo o disprezzarlo è sempre esercizio vano. Però non è vano confrontare il proprio tempo con altri nel passato, nella loro continuità e nelle loro differenze, per dare un senso alla percezione di un disagio nel presente, oppure di qualche opportunità. Nella poesia, il confronto con il passato e l’attenzione alle conoscenze del presente ci impongono di rilevare il debordare attuale della velocità in superficialità, così come il privilegio della risposta emotiva impoverisce l’esperienza del fare artistico e della poesia in particolare. La poesia poco si avvantaggia, infatti, delle recenti tecnologie della comunicazione, e anzi si potrebbe dire che ancora non ha prodotto alcuna controparte davvero attrattiva. Sul piano formale, del resto, l’incontro con le suddette tecnologie, lungi dal proporre novità formali, ha fatto sì di restringere il rapporto poeta/testo/lettore a un meccanismo di istantanea empatia. Le arti sono in costante mutamento, come lo è la vita umana sulla terra. E opporsi al mutamento è una stupidaggine. L’intenzione che ha animato questo lavoro è quella di aprire negli eventi in mutamento degli spiragli di riflessione che trovino concreta e seria conseguenza nell’operare di chi fa la poesia e di chi la legge. Alla superficialità dell’empatia istantanea si vorrebbe contrapporre la dimensione dell’indugiare intenti, ovvero quell’aprirsi della mente che – co-operando nel corrispondere delle forme e della materia che compie l’opera – ricompone il rapporto tra l’impermanenza dell’istante e l’effondersi della percezione. Più intenso è il coinvolgimento nell’opera, più la percezione si sottrae al semplice scorrere del tempo, più è coinvolta nelle corrispondenze con la materia terrestre. La mente ritorna, di continuo, però, dalla condizione di “estasi” nel tempo dell’opera, al tempo abituale, al qui e ora del corpo, e commisura, confronta, elabora configurazioni.
Il museo è il tempio dell’arte? Oppure è la banca del mercato dell’arte? O ancora è la riserva di credito dell’arte che permette il generale indebitamento dell’estetizzazione istantanea multimediale? In ogni caso è uno spazio in cui si conservano e insieme si rendono disponibili le opere alla fruizione. In ogni caso vuole il gesto di accostare le opere e fruirne, che comporta l’impegno di entrare nel museo (pagando al più spesso un biglietto) e richiederebbe un atteggiamento disposto alla ricezione dell’opera nella sua vicenda di tempo e di luogo (ovvero il tempo-luogo presente e quello che ci separa dalla sua realizzazione). In ogni caso per quello spazio qualcuno si è preso la responsabilità di decidere che si tratta di uno o più esemplari artistici di valore e di riferimento per quella specifica cultura. Il museo virtuale promette un’“esperienza immersiva” e un’agevolazione didattica. In altre parole, trasforma l’esperienza dell’arte in intrattenimento. Può essere buono e utile intrattenimento, o cattivo e inutile intrattenimento, questo è chiaro. Per l’istruzione un intrattenimento buono e utile è molto meglio di una cattiva didattica tradizionale, e può fornire l’occasione per un ripasso, una discussione e un rinforzo. Però devo raccontare quello che mi è accaduto. Forse l’errore è stato mio. Tornando a visitare la Madonna del parto di Piero Della Francesca a Monterchi, sono entrato a vedere prima il cortometraggio annunciato come importantissimo per la miglior fruizione dell’opera. Non mi ricordo se a tale sequenza – prima film e poi opera – sono stato indotto dalle indicazioni dell’allestimento o se è stata una decisione mia. Un grande schermo, casse acustiche efficaci, la musica, una suadente voce fuori campo e immagini belle, veloci, particolari esaltati, schemi delle figure ruotati di 45°, di 90°, tutto acceso di colori brillanti, veloce. Finito lo spettacolo, prima che riprendesse il loop, mi sono mentalmente complimentato con chi aveva realizzato il film. E poi sono entrato nella stanza dove attendeva l’opera. Piccola di dimensioni, i colori tenui, mortificata da un vetro verdastro che la proteggeva, la Madonna del parto mi appariva molto meno attraente di quanto avevo visto poco prima. Quasi un sottoprodotto. Ho dovuto fare appello alle mie certezze, alla mia esperienza di anni di dedizione a Piero, dilettantistica certo, ma non per questo meno sincera, per iniziare a ritrovare quei motivi di stupore e di gioia che l’opera suggerisce, per indovinare ancora una volta l’enigma e mancarne felicemente lo scioglimento. E durante, e dopo, e ancora il giorno successivo, mi è rimasto un senso di disagio che non se n’è più andato. La percezione, la sensibilità, l’emozione si possono drogare. Questo è quanto ne ho ricavato, estendendo quell’esperienza a molte altre dell’attuale panorama estetico “multimediale”. L’impatto sensoriale, aumentato oltre un certo limite, se ben condotto fa questo effetto: produce un piacevole imbambolamento, un godimento generale che si avvicina alla trance. Sempre più veloci le immagini, sempre più impattanti il colore e il suono, sempre più inatteso lo sviluppo, sempre più violento tutto. Una super-arte che forse è tutta l’arte di oggi, rispetto alla quale le altre forme artistiche sono sopravvivenze, e forse un appello ultimativo all’arte come fino a oggi è stata pensata e fatta? La “serie” invece che il film, ancora meglio se in un unico blocco di molte ore. L’“esperienza immersiva” invece che il quadro, o la musica, o altro ancora. In attesa dell’“esperienza immersiva” della poesia, la commistione di scrittura, immagini, notizie personali, chat, performance è già in atto. Forse è soltanto il fatto che tutto diventa più veloce e simultaneo: “È la tele-globalizzazione, baby!”. È ora che me ne faccia una ragione. È vero, e va considerato, che la modalità propria della comunicazione della poesia, costituita e circoscritta nel perimetro della tradizione in quanto pagina cartacea, è oggi esposta alle nuove forme di comunicazione sociale e alle conseguenze estetiche dell’evoluzione tecnologica. È un ragionamento che abbiamo già proposto: mentre la comunicazione generalmente veicola e rende operativi i significati e i simboli socialmente condivisi, al fine di innescare dei processi che hanno nei diversi ambiti della società i relativi effetti, la tradizione dell’arte costituisce a sistema comunicativo un ambito specifico dell’operare, cioè circoscrive quanto è socialmente trasmissibile di ciò che è proprio dell’arte, la quale è quell’esperienza che interroga la percezione e l’esistenza psichica. La tradizione è l’area di quell’indugiare, ovvero quella diversa temporalità, che riguarda la fruizione artistica, ove la “simultanea irriducibilità e asimmetria di percezione e comunicazione” incrociano le forme sul piano della loro continuità e discontinuità. Mentre la comunicazione invade sempre di più lo spazio dell’estetica, cancella ogni indugio e accelera la chiusura di ogni circuito comunicativo (fino a sostituire l’emoticon alle parole). La tradizione, detto diversamente, è la rete; la poesia è il pesce. Se è vero che non si deve mai confondere la rete con il pesce – un fatto che può avere pessime conseguenze – è altresì vero che senza la rete il mare resta pieno di pesci che non riusciamo mai a pescare. Se scrutiamo nei tempi diversi della lunga tradizione della poesia, rileviamo che non sono mancati squarci e rammendi alla rete – per continuare l’immagine metaforica – né nuove reti fatte di materiali diversi; e c’è stato chi ha tirato su un gran pesce con una lenza e chi l’ha catturato a mani nude (ma i casi sono rari e isolati, paragonabili a quelli dei validi musicisti che non hanno mai conosciuto un’ora di apprendimento musicale tradizionale – però anche questi hanno incontrato la musica in un “contesto di tradizione”). In altre parole, proclami, comportamenti, gesti estremi, vicende biografiche, situazioni sociali, relazioni vincenti con il pubblico, nuove tecnologie, sono sempre state parte della vita della poesia. E la modernità è stata sotto numerosi riguardi il teatro sociale che ha visto portare alle estreme conseguenze l’equivoco della diversità e dell’esotismo come sostituti del labor indefessus per rispondere a una chiamata che non è indirizzata a un “io”, ma a qualcosa che lo inquieta. Un’inquietudine che può essere simulata, è ovvio, e rende possibile mostrare il salto mortale sulla scena sociale senza essere sfiorati dal vero pericolo. Un equivoco che diventa totale fraintendimento quando l’opera non fa più differenza rispetto alla comunicazione sociale nel circuito istantaneo globale. La tradizione era proprio l’agorà (o l’arena) nella quale questi aspetti collegati al fare poesia erano discussi, confrontati, chiamati a forza a mostrare le proprie carte e a giocarle sul piano di quel “discorso comune” che la tradizione stessa garantiva. Anche generando fratture all’interno delle istituzioni. Anche contrapponendo critica e poesia, per esempio. Oppure teoria e poetica. Oggi vediamo che per molti aspetti della vita quotidiana questo appello a un “discorso comune” non solo viene disatteso, ma è assente, anzi pare che avvenga il contrario: tanto più appare efficace un gesto comunicativo quanto più si sottrae al confronto con il “discorso comune” al suo contesto o lo nega. Con il seguente risultato: ci sono atteggiamenti e parole che tendono a ottenere il massimo del consenso in quanto poesia sottraendosi o negando qualsiasi “discorso comune” sulla poesia. Le parole “emozione” e “comunicazione” hanno preso il posto di ogni ragionamento, di ogni indugio, e hanno messo in primo piano il gesto o il dato biografico, assumendoli quasi a genere letterario totale. È certo che queste riflessioni corrono il rischio di fare ulteriore accumulo sul monte di analoghe critiche (e spesso semplici “lamentele”) che ricorrono in ogni epoca nei discorsi sull’arte in genere e sulla poesia in particolare. L’intento è quello di invitare a pretendere molto, e sempre di più. Dobbiamo però affrontare un altro argomento, non di poco rilievo. Non è di oggi, infatti, la messa in questione della tradizione dell’arte come luogo proprio dell’origine dell’arte stessa. Questo l’abbiamo già dato per acquisito con il precedente esempio metaforico della rete e del pesce. È il motivo che ci ha invitato a scrivere i primi capitoli, con i quali abbiamo cercato di fornire alcuni elementi per la considerazione del rapporto tra lo stare sulla terra del corpo-psiche e la relazione con il fare e il fruire l’opera d’arte. Però ancora oggi permangono non pochi equivoci al riguardo. La conoscenza e l’esercizio delle regole tradizionali di versificazione, la coscienza dell’evoluzione delle forme poetiche, i cosiddetti “ferri del mestiere”, insomma, sono i presupposti sufficienti per fare poesia? La risposta è semplice: no. Ma hanno una loro ragione di necessità: non appena si entra in relazione con la poesia vi sono domande e risposte che troviamo già disponibili nella tradizione lungo percorsi riconoscibili. È meglio trovare una rete che dobbiamo rammendare e in parte ricostruire invece che rifarla da capo filo per filo. Oppure pensiamo di cavarcela con una trovata? Certo, la rete non è il pesce. Ma questa è un’acquisizione recente, rispetto alla lunga vicenda della poesia. Per secoli si era buoni o cattivi poeti, senz’altro. Poi, per altri secoli ancora, si era magari versificatori (si seguivano tutte le regole) ma non veri poeti. Solo nel corso dell’Ottocento è venuta in evidenza, con sempre maggiore forza di provocazione, la distinzione tra la poesia come effetto dell’opera (e come suo originale costituire una forma) e i caratteri tradizionali del fare poesia in termini di lingua e di forme ereditate. La meditazione di Martin Heidegger sull’Origine dell’opera d’arte è stata, a questo proposito, al centro di molte successive riprese. Lo stile affascinante del “Mago di Messkirch” rischia di irretire, ma siamo in grado di ricavare alcuni snodi fondamentali, non ignorati nelle pagine precedenti. Prima di tutto c’è che l’opera non può essere pensata senza che sia pensato l’operare di chi ne determina l’evento: il poema ha origine nel poeta come il poeta ha origine dal poema. Qui non è in gioco “che cos’è la poesia?” o “chi è il poeta?”, come oggetto generale il primo e come soggetto generale il secondo, e neppure negli stessi termini il singolo poema e il singolo poeta che l’ha scritto. La creazione del poema, il fare poesia, crea il poeta come il poeta crea il fare poesia che diventa poema. La complessa strategia che Heidegger conduce nel corso di quelle pagine non si presta a facili riassunti. Si possono isolare però i due passaggi di maggiore importanza: il primo riguarda la sottrazione dell’opera alla sua mera oggettualità, ovvero al semplice insieme degli elementi oggettivi (parole, colori, suoni, ecc.) di cui è fatta; il secondo l’individuazione di uno spazio proprio della relazione tra artista (nonché fruitore) e opera rispetto a ogni altra dimensione comunicativa. Il punto forse più determinante è quello che, senza confonderli, lega artista e fruitore in un comune coinvolgimento con quello che non è tanto l’opera-oggetto, quanto con ciò che Heidegger chiama “l’operare dell’opera”. Che artista e fruitore non vi siano distinti non è un trucco, né una mancanza, ma il rilievo che non si tratta di una “risposta” che riguarda le abituali esperienze vissute, ma l’accesso a una dimensione dove esse sono momentaneamente sospese e “aperte”. Ancora una volta vale la pena di insistere sull’indugiare. Orazio (Satire, 1.9) scrive che, mentre è intento alla composizione di alcuni versi, sta totus in illis. Indugia, cioè, in una dimensione che non ha direttamente a che fare con quanto succede intorno a lui, o quanto gli è accaduto, ma concentra l’intelletto e la percezione all’interno dell’“operare dell’opera”. Intus legere, sarebbe meglio dire, all’infinito, invece che usare il participio/sostantivo intelletto. Totus in illis si apre all’intus legere, nella dimensione in cui la percezione del vissuto è presente e allo stesso tempo sospesa. È difficile sciogliere il linguaggio di Heidegger in qualcosa di agevole da riassumere, ma potremo dire che scrivere/leggere una poesia è un “sostare” in quella dimensione in cui la percezione del vissuto è sospesa e aperta; ma non si tratta di un sostare inerte, bensì di un coinvolgimento nell’operare dell’opera. Qualcosa di “assolutamente diverso dall’apprezzamento specialistico fondato sul gusto del formale nell’opera, delle qualità e del fascino”. Un argomento che richiederebbe molto spazio è quello che riguarda l’esperienza dell’autore in quanto fruitore della propria opera, non solo dopo che è stata “abbandonata” (Alberto Giacometti non si stancava di ripetere che “un’opera d’arte non può mai dirsi finita. Semplicemente la si interrompe o la si abbandona”). E neppure intendiamo affrontare un altro tema, quello del “pubblicare”, come nuova distanza dall’opera, che molti poeti, scrittori e artisti hanno testimoniato. Si intende puntare l’attenzione sul fatto che l’autore è costantemente anche il fruitore, il suo operare alla creazione dell’opera è anche esperire per sé ciò che l’opera mette in opera. L’operare dell’opera non è quindi nelle sue convenzioni o nei suoi modi tradizionali di acquisire una forma adeguata, ma nella capacità di produrre una “sorpresa” e uno “spaesamento” nell’ambito percettivo e in quello psichico. È il suo spiazzare, inquietare, quello che Heidegger definisce come Stoss, ovvero è con la sua piccola o grande impronta traumatica e “risvegliante” nei confronti delle attese percettive e psichiche che l’opera attua la “messa in opera” del suo originario accadere. È convincente, e allo stesso tempo si presta a stornare un possibile equivoco. L’operare dell’opera, mentre inquieta e risveglia la relazione tra le configurazioni abituali e la logica discorsiva che le ordina, attua allo stesso tempo una riconfigurazione o la chiede disperatamente sul limite di un possibile (e – perché no? – del fallimento di questa possibilità). Il principale equivoco sarebbe trascurare quanto Heidegger scrive nei termini di “operare dell’opera” e confondere questo indirizzo di pensiero con la scena pubblica in cui lo Stoss si realizza in termini di comunicazione sociale. È forse la questione principale dell’arte del Novecento, che ha visto gridare al capolavoro e all’impostura nei confronti di uno stesso artista o di intere tendenze. Non è qui il momento per proseguire su questa strada. Però è oggi il tempo che vede esplodere questo conflitto. È soprattutto il momento per dare ragione del titolo di questo libretto e del suo scopo, così come di giustificare tutte le pagine precedenti. La poesia è “opera” (sostantivo) in quanto “opera” (verbo) originariamente nell’ambito che le è proprio, con la propria originaria materia. Non è un gioco di parole. La poesia è l’opera dell’operare con e nella lingua. È la lingua l’ambito e la materia del suo operare. È nella lingua che avviene o non avviene lo Stoss di cui scrive Heidegger, non nei suoi contenuti relativi alla comunicazione sociale. Qui è necessario però porre in evidenza qualcosa che rimane perlopiù sottaciuto, e che ci richiama per necessità alla tradizione: nella nostra cultura l’operare dell’opera poetica avviene coinvolgendo la scrittura nell’ambito e nella materia della lingua. È importante, dal momento che la scrittura è il riferimento non discusso di ciò che diciamo “poesia” tanto nella tradizione quanto in tutte le forme dell’attualità, sia l’instapoetry o la performance. Ritornando a quanto già scritto: la poesia avviene per tacito universale consenso in quanto composizione scritta. Perché tanti secoli di cultura poetica avrebbero identificato l’operare dell’opera di poesia nella composizione scritta, ovvero nel rapporto tra lingua e scrittura? Non è certo soltanto per la conservazione della lettera del testo. Abbiamo visto che la scrittura apre e sospende lo spazio della composizione, permette nell’operare il farsi dell’opera. Quando alla fine del XI secolo la poesia inizia il suo nuovo percorso nella lingua volgare, in Provenza, si presenta a voce viva e con una veste musicale. Certo la “musica” è elementare, ma è in questa modalità che si offre. Ma se nasce così opportunamente “vestita”, per quale motivo, in un tempo tutto sommato per allora breve, la forma scritta prevale fino a diventare finalmente del tutto autonoma? Se la presenza della musica fosse davvero un “di più”, perché si sarebbe andati incontro a un “di meno”? Forse perché la poesia ha la sua musica. Forse perché la voce della poesia non è di qualcuno che “a voce viva” la dice, ma è interna alla composizione della lingua scritta. Diciamo “La mia lingua”. Anzi, c’è poco altro di “mio” come la nostra lingua. È mia, certo, però più nel senso che sono questa lingua e molto meno nel senso che la ho, la possiedo. L’ho ricevuta, infatti, già piena di tempo e di mondo, di esperienze, di senso e nonsenso. Vivendo mi ha accompagnato, l’ho attraversata (ci siamo attraversati) e mi ha portato gli altri, altre vite, esperienze, tempo. Mi ha portato l’amore e il lutto. Ha portato me agli altri. La lingua, questa meravigliosa lingua, quanto tempo, quanti tempi accoglie e distingue? Quanti luoghi accoglie, quali itinerari ci offre? Ho scritto che la mia lingua è meravigliosa. Chi non si compiace nel sentirsi lodare la propria lingua, chi non si sente disturbato, se non offeso, nel sentirla denigrare? Nel periodo più intenso di vitalità pubblica della poesia neodialettale, durante gli anni ’90 del secolo scorso, c’era una comunità itinerante di poeti, alla quale un poco appartenevo, che portavano le parlate dei loro luoghi di vita all’incontro con altri. Il confronto delle diverse espressioni era ricco, vivificante. Però non mancava mai chi diceva che la sua parlata era di per sé poetica, sentendosi emotivamente coinvolto e commosso dalla sua stessa appartenenza a quell’idioma. Un eccesso e un errore: la poesia si fa con la lingua, non è data. Ma è il segno di quanto grande sia il coinvolgimento di ognuno di noi con il proprio parlare, e di quanto la lingua non sia solo veicolo, ma essere molteplice che nel nostro parlare trova l’evento di un’unità che salva e mantiene latenti tutte le differenze. La poesia che si fa, con la nostra lingua, viene pensata come qualcosa che si fa con la scrittura. Come è più facile rilevare quanto la voce viva sia più efficace della scrittura, così viene quasi istintivo pensare che la voce intonata con la musica dia alle parole ancora qualcosa di più. Non è vero. Non è qualcosa di più. Né qualcosa di meno. È un’altra cosa, che potrà anche piacere di più, ma non è poesia. Ha molte caratteristiche della poesia, prima di tutto la composizione, ma la presenza della musica fa assumere alla comunicazione un altro percorso creativo, con diversi risultati. Ci può essere una canzone (e altre forme espressive che usano le parole) bellissima e ci può essere una brutta poesia, ciò non cambia niente per la questione che affrontiamo. Il problema riguarda in parte la stessa lingua italiana, che non ha due parole diverse per dire “Questo timballo è una poesia” e “L’infinito è una poesia”, anzi, l’italiano non distingue neppure la singola composizione, che chiama “poesia”, dall’operare poetico di un autore nel suo insieme, ovvero “La poesia di Leopardi”. Facciamo conto che l’ambiguità generata sia una ricchezza linguistica, non una scusa per alimentare equivoci. Torniamo un’ultima volta sulla composizione. Se abbiamo colto le questioni più importanti quando abbiamo parlato del verso, della memoria, delle ricorrenze e delle mancate ricorrenze della lingua, nonché delle diverse scelte tonali e lessicali, allora dobbiamo insistere sul fatto che la poesia esalta i caratteri che avvicinano la composizione poetica a quella musicale. Nella musica, distinguiamo infatti diverse voci, anche se sono simultanee, diversi strumenti, alcuni impegnati nella melodia, altri nel ritmo. Il rapporto tra la sequenza dei versi e il loro ragguppamento strofico agisce in modo analogo. Potremmo riportare dal mondo dell’intelligenza artificiale una suggestione (non di più, dato che chi scrive è lontano dal padroneggiare la materia): la differenza tra intelligenze che lavorano in modo lineare e intelligenze che lavorano in parallelo. Se il cervello, come vuole oggi una parte della scienza neurologica, è modulare, allora davvero si potrebbe pensare a moduli cerebrali che elaborano nello stesso tempo informazioni diverse. E così chiamano in causa la memoria profonda, mettendo in crisi la memoria di lavoro. In altre parole, la composizione verso/strofa istituisce relazioni di suono e di senso che attivano moduli ordinari dell’interpretazione verbale e insieme altri più a fondo legati alla percezione e alla psiche. Ne sapremo di più quanto più in là, con il tempo, la neurolinguistica riuscirà a giungere negli esperimenti che interessano la relazione suono-senso-materia nei processi cerebrali. Sotto l’aspetto fenomenologico la questione del ritmo come orientamento dell’attenzione, attesa, tensione, unificazione di elementi distinti e chiusura dell’attesa medesima, ha già offerto contributi diversi e di sicuro interesse. Quanto appena scritto suona aleatorio, sotto molti aspetti, e indica soltanto una direzione di indagine possibile, segnalando più le suggestioni che i risultati applicabili, soprattutto per la didattica, che resta l’unico centro attuale della comunicazione sociale della poesia. Però il percorso generale fin qui delineato ci permette alcune riflessioni riassuntive e per molti aspetti decisive, che ci portano nel cuore della questione. La questione è il legame tra parola e scrittura e il fatto che la poesia chiede da secoli di essere considerata in quanto composizione nella forma della scrittura. Allora siamo invitati a insistere sulla differenza tra voce viva e scrittura, alla luce di una concezione causativa della relazione umana nella parola, e nella piena considerazione dell’importanza del tema della lingua in questo contesto di ragionamento. Quando ascolto la parola detta, che mi arriva attraverso la voce viva di un altro, a portata d’orecchio o registrata, riconosco un’identità, un’impronta che veicola determinate caratteristiche che comportano effetti specifici sulla mia percezione e sulla mia psiche. Abbiamo aggettivi per descrivere le voci e intere frasi per dire l’affetto che ci fanno. Si usano per i cantanti e per gli attori. Quanto più sono particolari, tanto più sono riconoscibili e determinano già per sé una relazione tra un ambito di senso e il “testo” veicolato. La capacità di esaltare i valori di un testo è, però, direttamente proporzionale a quanto altri valori risultano depressi. Una voce viva è la voce di qualcun altro, che io conosco o immagino, ma che in ogni caso mi porge in primo piano la sua impronta corporea sonora, prima ancora della sua interpretazione. E poi, ancora, quell’interpretazione che non è qualcosa d’altro dalla voce, ma in essa si radica a fondo. Basti pensare, a questo proposito, che i produttori di audiolibri, mentre in un primo momento cercavano di ingaggiare attori noti per meglio attrarre il pubblico, si sono resi conto (non appena l’attore noto ha registrato due libri molto diversi) che la riconoscibile personalità dell’interprete caratterizzava troppo l’ascolto. Meglio un attore meno noto, perché la sua voce risulta più neutra, e perciò ottiene di forzare meno gli effetti di ricezione dell’ascoltatore. Li lascia più liberi. Ma liberi di o da che cosa? Di ascoltare la voce del testo. Non siamo ancora arrivati al punto: di chi è, dunque, “la voce del testo”? La voce del testo non è la voce dell’autore. Qualora fosse l’autore a leggere il testo da lui stesso composto, fornirebbe forse degli elementi di interpretazione interessanti ma, di fatto, si troverebbe nella medesima condizione dell’attore. La voce del testo, infatti, è quella che l’autore ha composto dentro il testo nella forma più adeguata al miglior risultato raggiungibile. È evidente che la stessa voce narrante (e non solo quelle dei personaggi) può risultare diversa da un’opera all’altra dello stesso autore. Ci sono poeti che lavorano all’incontro della loro voce “teatrale” con la voce della composizione che loro stessi scrivono: è un percorso che complica quanto fin qui affermato, ma non ne intacca la validità. Per quanto riguarda la composizione poetica, questa semplice verità risulta oscurata dal coincidere quasi totale del genere “poesia” con il sottogenere “lirica”, la quale, a fare un paragone semplificante, ha il carattere di un monologo teatrale che ha come attore e personaggio lo stesso autore. Chiarito l’eventuale equivoco, resta da considerare un fatto: è nella lingua che l’autore trova la voce del testo (poetico e non), incarnandola in un corpo di parole che dalla lingua assume la sua materia vivente, immaginata e realizzata per mezzo della composizione. La composizione dell’autore è la sua voce esposta, nella lingua, alla voce di altri che diventa voce di un altro che è il testo stesso. Il gesto retorico del voler dire, mediante la composizione assume i tratti di un’alterità che produce un soggetto linguistico identificabile con l’opera stessa. Abbiamo detto che al gesto retorico del voler dire si contrappone il gesto ermeneutico di chi ascolta. Quando, invece che la voce viva, l’ascolto mediante la lettura riguarda il testo che è stato composto, che cosa accade? Non è, infatti, la stessa esperienza di quando si ascolta una voce viva. Sono le mie strategie di lettura, se vogliamo chiamarle così, o meglio è la mia capacità di recepire tutte le suggestioni di lettura della composizione a dare voce al testo. Per farlo, le parole devono attraversare il mio universo linguistico e le configurazioni di senso che in esso operano, comprese quelle relative al suono che prende forma nella mia mente. Il testo viene letto con la mia voce. Allo stesso tempo, però, quella voce mantiene una sua alterità, diventa voce altra, senza essere voce di qualcun altro. Sono nella lingua, nell’esperienza percettiva e psichica della mia esistenza che la pervadono, le risorse per dare voce all’altra voce, che proviene dal testo, che non è voce di qualcun altro ma voce dell’opera. E la poesia, dunque, ancora. La voce viva si estingue nel testo, per configurare una voce nuova, altra, irriducibile a qualsiasi voce viva che lo pronunci. Questa alterità non viene meno, qualora di volta in volta, come accade per il teatro, diverse voci di qualcun altro incarnino questa alterità. Ma il teatro è un’arte che, a questo riguardo, esige di essere distinta dalla poesia che, come abbiamo visto, non ha il suo proprium nella presenza sulla scena ma nella lettura. La voce si estingue, ma non per scomparire. La voce si estingue per rinascere attraverso la lettura come voce altra del lettore. Nell’indugiare, che è sostare nell’operare dell’opera, si sospende la relazione abituale con il vissuto e la percezione si apre a un intus legere nella lingua che è propria e di altri, del presente e del passato, attiva in un “mentre” che inscrive nel passato/presente l’ipotesi di un tempo a venire. Il poeta diventa voce di sé e di un altro come per il lettore la poesia diventa voce di un altro e di sé. Per rifarci a quel titolo tradotto con La setta dei poeti estinti dal quale abbiamo preso l’avvio di questo libro, ogni poesia è la voce di un poeta, che con un po’ di ironia diremo “estinto” in quanto voce viva, ovvero soggetto di una performance live variamente intessuta alla biografia, per diventare voce di sé e di un altro per ogni lettore. I poeti che accettano di diventare “estinti” nella voce viva per far nascere la voce della poesia, non possono esimersi dall’ascolto della lingua. Viviamo infatti immersi nella lingua perché parliamo con gli altri, ascoltiamo, scriviamo, leggiamo gli altri continuamente, in quel brusio della lingua che fa il mondo con tutti i suoi ingressi, le sue uscite e le sue vie di fuga. Viviamo immersi nella lingua anche quando parliamo e ascoltiamo noi stessi dentro noi stessi, quella stessa lingua che ci rende parte del mondo degli altri. Le parole prendono un suono, dentro la nostra mente, si sentono nascere come gesto, anche quando non le pronunciamo a voce viva. Se accadesse di dire a voce viva tutto quello che ognuno di noi dice di continuo dentro la propria mente e se ci fosse la possibilità tecnica di ascoltare le risposte, ovvero il dialogo a due, a più voci che continuamente siamo, verremmo subito indirizzati da un terapeuta. Non è casuale che Agostino, mosso da intenzioni moralizzanti, voglia eliminare l’arte profana ma soprattutto il teatro. Agostino va a fondo nel pensiero, perciò comprende che c’è qualcosa che ci unisce agli altri tanto che anche la finzione ci commuove, ci porta a provare compassione. E il suo intento morale dice che si tratta di una compassione sprecata, di un auto-inganno, di una presa in giro della verità e dell’amore che alla verità è legato a doppio filo. Vorrebbe che il dialogo interiore fosse riservato solo al confronto con la propria anima al cospetto della voce di verità che da essa proviene, che ci lascia indovinare la voce della divinità. Agostino cerca di cancellare la tentazione, la promiscuità, l’errore, perché ha ben compreso che siamo in dialogo con noi stessi attraverso gli altri, molti altri, anche chi non conosciamo, nell’esperienza quotidiana della lingua. La lingua fa sì che dentro di noi ci siano gli altri, anche quando non ci sono: i fin troppo famosi “neuroni specchio” forse sono già attivi dentro la lingua, e nella lingua possiamo esplorare il nostro volto, ma anche perderci in un labirinto di specchi. La poesia è bella quando opera a ricomporre il rapporto tra percezione e psiche nella forma dell’opera, nel modo della composizione che le è proprio da secoli dentro la pratica della scrittura. Può non riuscirci, e diventare una brutta poesia. Se rinuncia a questo compito, non è una brutta poesia, è qualcos’altro che non è poesia.