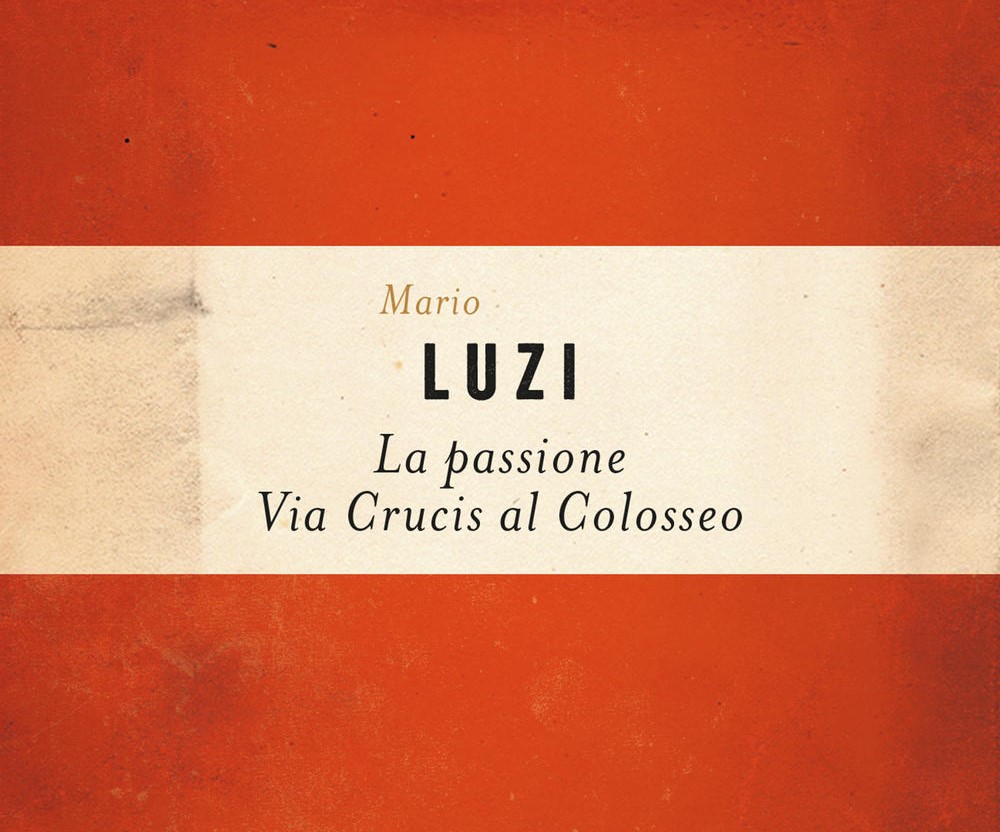(Salmi 23, 4)
A volte le azioni più crudeli consentono all’amore di depositarsi e di trasformare la realtà. Se la passione avesse un colore di riferimento non sarebbe solo il rosso, ma anche il nero, ovvero le gradazioni della terrestrità sofferta da Pavese, del sangue rappreso intorno alle piaghe di Cristo che s’impasta alla polvere durante il suo calvario, che non è ascesa bensì crudele salita. Mario Luzi delinea così La passione composta per la settimana santa del 1999, in occasione della Via Crucis al Colosseo presieduta da Giovanni Paolo II. Seguendo gli stralci evangelici che raccontano le stazioni tradizionali, l’esistenza del Messia scivola irreparabilmente nella notte, «alla casa dove convengono tutti i viventi»[1]; una notte necessaria per avverare le Scritture che egli sente “rimediabile”, ma che teme con tutto se stesso. Essendo gli uomini destinati a conoscerla soltanto attraverso il cerchio della vita, il pensiero della morte e la sua ombra avvolgente sopraffarebbero chiunque, ma in poche interminabili ore il Figlio di Dio assimila quanto non sia altro che la fine del cammino, o meglio, parte di un cammino insondabile razionalmente, nonché figlia prediletta del tempo. È quella che il poeta definisce «tristezza del tempo» a introdurre il famigerato bacio di Giuda nell’Orto degli Ulivi, ossia la testimonianza della sua finitezza: «il tempo è degli umani, per loro lo hai creato / a loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle».
Se il dolore conferma i limiti degli esseri umani, la tristezza dimostra le radici dell’amore, i fiori e i frutti che hanno permesso negli anni dentro ciascuno e come un solco perdura il loro lascito. «L’angoscia che mi leggi in viso / e nel cuore è quella del presentimento»: comincia così il poeta nelle vesti di Gesù, coinvolgendo subito il lettore, ma senza esagerare con il pathos nella sua perorazione; lo coinvolge con un esercizio di sensibilità e non della mente, non grazie a un’intuizione, ma al sedimento delle emozioni.
I.
È l’accettazione dei propri limiti che consente a ciascuno di scegliere un amore luminoso per il prossimo, persino per Quinto Cassio Longino, e non un oscuro rancore per la sua lancia. Alla domanda straziante «Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprendono?», fa eco insofferente la versione dell’ultima cena di Anna Maria Carpi, che sempre nei panni di Cristo pare controbattere: «Io non li amo. // Ama il prossimo tuo come te stesso: / non ero in me quando l’ho inventato»[2], pur non dichiarando a voce alta la sua avversione per i commensali, pur tacendo il suo disprezzo per impedirgli di realizzarsi. Nella mancanza di consapevolezza degli apostoli sottolineata da Carpi, c’è la distinzione di Luzi tra rendersi conto delle rispettive colpe e non riuscire invece a comprendere il grande peccato universale per cui perisce Gesù.
«[…] Egli è qui per la rovina / e la resurrezione di molti in Israele. / Segno di contraddizione perché siano svelati / i pensieri di molti cuori»; il poeta riporta tramite il flusso di coscienza di Cristo le parole del profeta Simeone, poiché l’irrisolto si raggruma non tanto in Dio che giudica l’uomo, ma nell’uomo che continua a giudicare se stesso e gli altri. Contraddizione che si esplica nell’osservanza della legge, «ma con aridità di cuore», perpetuando così la mancata corrispondenza tra corpo e spirito: in quel non sapere il peccato originale si annida la radice del malessere, «[…] l’astio / d’un antico e inconfessato paragone / con la divinità». I più non riescono a concepire la “pochezza” di Cristo, la sua umiltà disarmante rispetto all’onnipotenza e al fuoco prevaricatore del Dio ebraico. Vogliono uccidere il trascendente che è in lui e vogliono farlo nel nome di Dio.
Sono tue creature, sono miei fratelli,
hai messo loro in cuore la sete di giustizia
ma la presunzione di saziarla
non viene da te, viene dal demonio.
Il giusto! Fu acceso quel desiderio
contro quale iniquità primaria?
Tua, Padre, oppure del maligno contro te?
Su questo principio non si placa
la controversia umana.
Ed ecco in nome tuo
succedono empietà, soprusi,
disegni miserabili, perfidie, ipocrisie.
Alcuni uomini giudicano altri uomini[3].
Tuttavia nella sabbia che lo prosciuga e lo sfinisce[4], Gesù ammette al Padre di aver posto troppa distanza tra sé e il popolo da purificare, quando parimenti era egli stesso a riaffondare in sé per ritrovarsi proprio nel Padre, dall’uno al Tutto. La contraddizione ritorna nel peso sfibrante della salita, nel peso insostenibile dell’exemplum, ossia della percezione tra quello che si può raggiungere e quello che deve assolutamente restare distante, come la luce inafferrabile del divino, l’impossibilità di guardare il sole.
II.
Sono dinanzi a loro, nel sinedrio,
mi scrutano i sommi sacerdoti,
mi vogliono colpevole,
covano contro di me pensieri perversi.
Mi provocano, irritati dal mio silenzio, mi consegnano a Pilato, mi schermiscono.
Applaude la turba dei miei simili,
si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta,
mi vogliono in croce,
strappano al procuratore la sentenza.
In che cosa li ho offesi che mi odiano a tal punto,
a che rancore danno sfogo su di me che sono il più vulnerabile?
Li guardo Padre come tu li guardi
ma il tuo ed il mio sguardo non sono comparabili.
Vogliono uccidere il mio divino in me
e vogliono questo in nome tuo…[5]
A uccidere lentamente Jeshua, passo dopo passo, è la massa che infierisce su un singolo disarmato, inerme, che a fatica si regge in piedi. È la medesima sensazione che trafigge le tempie del Pilato di Bulgakov quando lo ha davanti ai suoi occhi vacui per la prima volta, ma senza cognizione di causa; emicrania che il procuratore della Giudea riesce a ignorare con uno sforzo di volontà – anche se breve – concentrandosi sulle vane certezze del passato. Non c’è profumo di olio di rose, però, tra le pagine di Luzi che anticipi la venuta del figlio di Dio, solo l’incertezza di chi arranca tra una folla di scherno e ostilità verso la sua ultima notte. «Ma se quel dubbio vi tortura, allora / date una mano ai suoi persecutori / fate cuore al carnefice. / Per sciogliere un enigma così strano / la morte è lo strumento più sicuro[6]»; secondo Il Centurione di Giovanni Raboni è assai più “sicuro” ed efficace seguire ciecamente l’odore del sangue, abbandonarsi alla violenza senza inutili attese, senza accogliere il rischio e aspettare che la profondità dell’animo possa rivelarsi.
L’enigma del male non è nulla se paragonato a quello della mediocrità. Mentre testimoniavano, ho percepito il loro piacere. Godevano a comportarsi come miserabili davanti a me. La loro unica delusione era che la mia sofferenza non si vedeva poi troppo. Non che avessi voluto negare loro questa voluttà, ma semplicemente lo sbalordimento in me era molto più grande dell’indignazione[7].
Se il Cristo di Luzi si immobilizza smarrito di fronte alle storture dei suoi simili, quasi prevalga l’orrore sul mistero della creazione, Amélie Nothomb tenta di colmarlo con una logica rassegnata, a sprazzi amara e inesorabilmente contradditoria. La questione morale a cui accennano sia Raboni sia Nothomb si compie nell’attimo in cui il Messia di Luzi si stacca dalle sue spoglie mortali, appena spira: «Qui termina veramente il cammino. / Il debito dell’iniquità è pagato all’iniquità. / Ma tu sai questo mistero. Tu solo». La sua morte, sebbene inconcepibile, testimonia un’estrema coerenza, quasi bene e male siano polarità equivalenti, ma opposte, in mano agli esseri umani ed effetto del loro libero arbitrio.
III.
«What nails dropped out that hour?», «Quali chiodi si sfilarono in quell’ora?», chiede a sé e a chi legge Seamus Heaney in Westering, “Verso ovest”, rassegnandosi a un culto superficiale che non si avvera più nelle abitudini quotidiane, nei frangenti fugaci di aggregazione, neanche per coloro che ancora si inginocchiano ai piedi dell’altare. E conclude con un Cristo allunato, sommerso da seimila chilometri di polvere «untroubled», che non necessita più della gravità e di conseguenza delle colpe che arrugginiscono acuminate, ma che finisce per tenersi stretto alla croce con le sue mani: «Christ weighing by his hand[8]».
La passione di Gesù rimane un topos istitutivo dell’Occidente; oltre all’orma della grecità e al monoteismo designato da Abramo, la cultura arabo-islamica si è rivelata una linea portante della civiltà occidentale. Alcune delle più intense pagine scritte sulla vergine Maria, su Maryam bint ʿImrān, sono nel Corano. «Perché mia madre mi segue e non si allontana? / Così strazia il suo cuore / e il mio non regge al suo martirio»: il Cristo di Luzi non capisce come la madre possa sopportare il suo supplizio, specialmente vedendolo cadere e strisciare quasi agonizzante. Ma diversamente da quello che si aspetta, sono tre donne ad accompagnarlo sin sulla soglia, all’ultimo faticoso grido, «Maria sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala», le quali assistono al soldato che per prolungargli la pena lo disseta con una spugna imbevuta d’aceto dopo averlo sentito urlare il nome di Elia: «alle tre, Gesù gridò a gran voce: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Marco 15, 34-35). Intanto la paura e lo sgomento avevano provocato il vuoto intorno a loro; avevano allontanato gli uomini da loro stessi e dal prossimo, li avevano isolati e rabbuiati.
Conoscerò la morte. La conoscerò umanamente,
da questa angusta porta mi affaccerò su di lei
che tu, vita onnipresente,
non conosci se non per negazione.
Tre giorni durerà per me
l’esilio che per altri non ha fine
poi la vita mi richiamerà a sé
e avrà la vittoria. È previsto fin dal principio.
Quella pausa, Padre, m’impaura: è un luogo dove tu non sei
e io da solo senza te pavento.
Che cosa mi aspetta, chi governa
il nulla, il non presente… il non essente?
o è un inganno della veduta umana
ciò che io impaurito ti confesso?
Devo io portare la vita dove la vita è assente
e portarla con la mia morte…
e questo è il prezzo, questo supplizio.
E così, Padre, io vanamente ti tormento.
Più che la morte è la via per arrivarvi,
la via crucis, che mi dà angoscia
perché è dolorosa e aspra nelle carni
e spezza il cuore di Maria, mia madre,
perché infame e odiosa
è la ressa di questi uomini e donne
aizzati contro di me.
Mi prende e mi tormenta il dubbio
che il mio insegnamento sia fallito.
La mia permanenza sulla terra è stata vana?
È bella la terra che tu hai dato all’uomo
e alle altre creature del pianeta
scelto per loro in mezzo all’universo. Io non sono di questo mondo
eppure non potevo se non teneramente amarla
e ora quell’amore mi si ritorce contro
«Non è su me che voi dovete piangere»,
ho detto alle donne impietosite,
«ma sui vostri figli e su voi stesse.
La terra sarà fatta un luogo di dolore»
ma il mio sacrificio è scritto che li assolva.
Piango anche io, Signore, vedo
i miei fratelli che afflitti rifaranno questa via
nei secoli, nei millenni[9].
IV.
Dalle impetuose fiammate liriche delle poesie giovanili alla discorsività severa e pacata, e alla tenue tensione etica dei versi della maturità, Mario Luzi ha sempre mantenuto un equilibrio arduo e proprio per questo toccante, tra ricerca letteraria e autenticità umana, tra le ragioni della forma e quelle della testimonianza. Anche la sua passione n’è una prova; difatti non si tratta di una riscrittura poematica per attualizzare i momenti conclusivi della passio Christi, ma un tentativo di trasposizione secondo una personale ricerca religiosa e un’evoluzione esegetica dettata dalle esperienze mondane. Non si tratta altresì di un’operazione di riscrittura che Harold Bloom avrebbe condannato a prescindere, poiché avrebbe sempre e comunque sottratto qualcosa alla «sacra verità» della figura Christi[10], ma di una circospetta immedesimazione. Nemmeno ha a che fare con La gloria (1978) di Giuseppe Berto, il suo testamento spirituale rigorosamente in prima persona, che predispone il vangelo dallo sguardo obliquo di Giuda. Tuttavia anche Berto aveva alimentato il rovello cristiano dentro di sé, una ferita al costato sotto le vesti abituali a partire da La passione secondo noi stessi (1972), che l’accomuna a quella di Luzi per l’approccio dialogico. Lo stile che sceglie Luzi è il monologo interiore, rivolto a un’attenzione universale, ma più flessibile di qualsiasi altra esito in versi: «[…] un sistema ritmico che include la metrica ma non le obbedisce e solo in certi punti speciali la formalizza»[11]; “speciali” non quando stigmatizza il presente o rischia di rinnegarlo, ma quando riesce a rinunciare al suo tempo, a distaccarsene pur soffrendo e a dipanare il groviglio emotivo.
«Vi dico che di ogni parola vana che avranno detto, gli uomini daranno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato» (Matteo 12, 36). Ecco che la parola poetica per Luzi, epifanica e vibrante, vale quanto i gesti che ispira e motiva e, talvolta, perfino li supera affrancandoli dalla consunzione del tempo e dal silenzio.
La Parola è appunto l’attesa di una verità che si incarni e si tolga finitudine alla nostra finitudine, tolga limiti alla nostra finitudine. È l’incarnazione di Cristo, ed è poi la Pentecoste. Fino a che un’incarnazione di quel genere non è scesa nel continuum dell’uomo, la nostra finitudine era cieca[12].
Nella sua accezione più alta la parola annuncia e preserva il futuro dell’intera umanità; è compito dei profeti non anticipare né ostacolare il corso degli eventi, bensì custodire il progresso della rivelazione.
La vita sulla terra è dolorosa,
ma è anche gioiosa: mi sovvengono
i piccoli dell’uomo, gli alberi, gli animali.
Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario.
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto.
Sono stato troppo uomo tra gli uomini oppure troppo poco?
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito?
La nostalgia di te è stata continua e forte,
tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna[13].
La Via Crucis «dolorosa e aspra» può risolversi agli occhi di Gesù solamente quando la contraddizione tra spirito e pensiero non sarà dissipata. «Sempre, dal principio fino all’avvento del tuo regno / il bene e il male si affrontano. / Oggi va al male, secondo appare a noi, la palma». L’eterna contesa tra luce e tenebre appartiene quotidianamente al processo di ascensione, per sublimare le membra come l’acqua cambia stato in vapore grazie a un aumento della temperatura e della vibrazione tra le particelle costituenti; perciò la dicotomia originale si scioglie con la propagazione del calore, con un eccesso di sentimento.
Cristo ha la certezza soprannaturale, ma le sue angosce sono umane; e questa è la condizione nostra; insomma, se pensiamo di aver chiara la grammatica universale, le conseguenze logico-sintattiche, siamo degli illusi. C’è la dismisura fra quello che possiamo vedere e quello che possiamo comprendere. Incolmabile. A noi non resta che registrare, sotto specie di infinito, questo nostro desiderio di infinito[14].
Non a caso, Mario Luzi chiude con un coro in preghiera e con la speranza che nessuna pietra sepolcrale possa fermare mai la vita: «Noi con amore ti chiediamo amore».
NOTE:
[1] Giobbe 30, 23.
[2] A. M. Carpi, L’asso nella neve. Poesie 1990-2010, Transeuropa, Massa, 2011, p. 41.
[3] M. Luzi, Gesù condotto di fronte alle autorità terrene, vv. 15-27.
[4] «Ha spezzato i miei denti con la sabbia, / mi ha steso nella polvere»; Lamentazioni 3, 16.
[5] M. Luzi, La sentenza, vv. 1-15.
[6] G. Raboni, Gesta Romanorum, in Tutte le poesie (1951-1998), Garzanti, Milano, 2005, p. 17.
[7] A. Nothomb, Sete, Voland, Roma, 2020, p. 10.
[8] S. Heaney, Traversare l’inverno. Poesie, a cura e traduzioni di M. Sonzogni, Gabriele Capelli, Mendrisio – CH, 2019, pp. 158-61.
[9] M. Luzi, Gesù incontra le pie donne, vv. 1-41.
[10] In Ruin the Sacred Truth. Poetry and belief from the Bible to the Present, Harvard University Press 1991, Harold Bloom sottolinea come autori del calibro di Oscar Wilde, William Butler Yeats, Ezra Pound e T.S. Eliot avessero rovinato la verità cristologica nella sua complessità per farla loro.
[11] M. Luzi, in Premessa alla passione, p. 6.
[12] Idem, Colloquio. Un dialogo con Mario Specchio, Garzanti, Milano, 1999, p. 182.
[13] Id., Gesù e la vita degli uomini, vv. 19-27.
[14] Id., quasi privato, a cura di C. Ruzzi, LietoColle, Faloppio, 2001, p. 30.
MATTEO BIANCHI (Ferrara, 1987) si è specializzato in Filologia moderna a Ca’ Foscari sulla poetica di Corrado Govoni. Nel saggio "Il lascito lirico di Corrado Govoni" (Mimesis, 2023) ha messo in relazione i profili di Giorgio Bassani, Roberto Pazzi, Angelo Andreotti e altri scrittori emiliani contemporanei. Ha pubblicato le raccolte "Fischi di merlo" (Edizioni del Leone, 2011), "L’amore è qualcos’altro" (Empirìa, 2013), "La metà del letto" (Barbera, 2015) e "Fortissimo" (Minerva, 2019). È redattore di Pordenoneleggepoesia.it e dirige il semestrale “Laboratori critici” (Samuele Editore); come giornalista scrive per “Il Sole 24 Ore”, “Left”, Globalist.it e “Il Foglio”. Dirige il Centro Studi “Roberto Pazzi” della sua città.