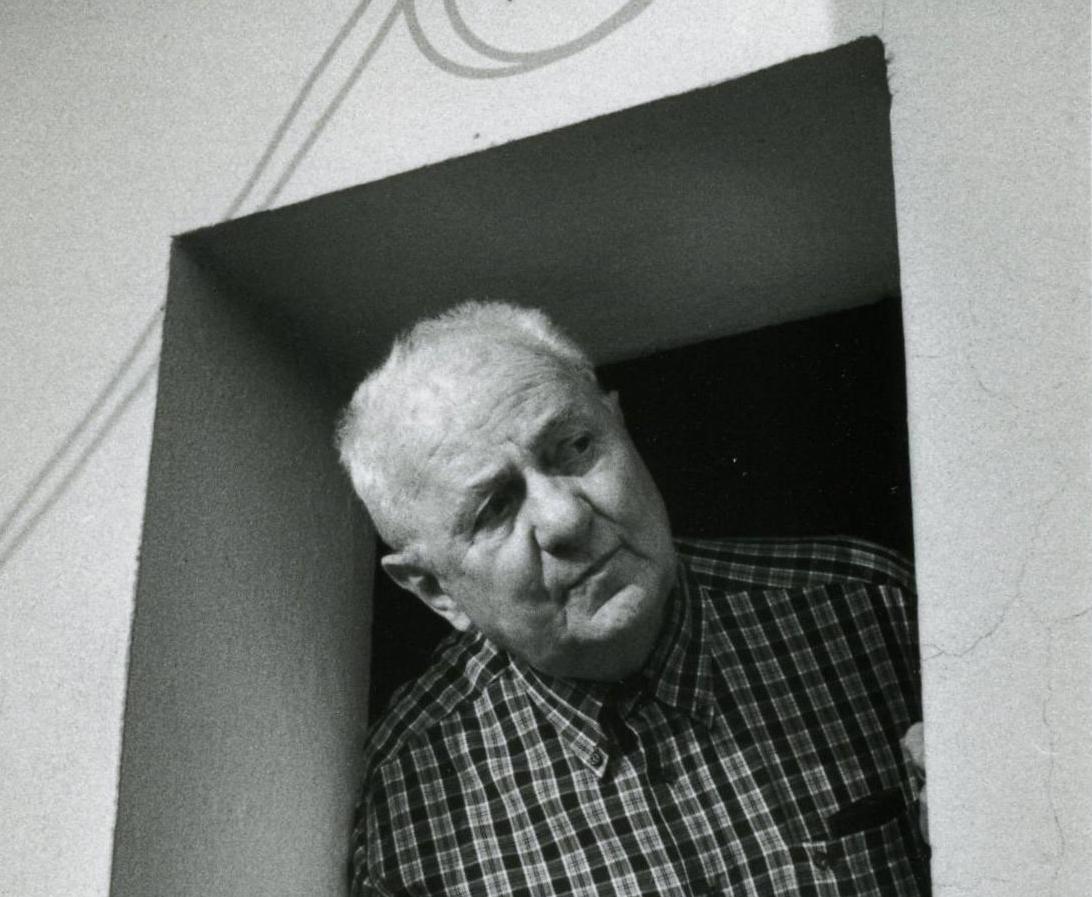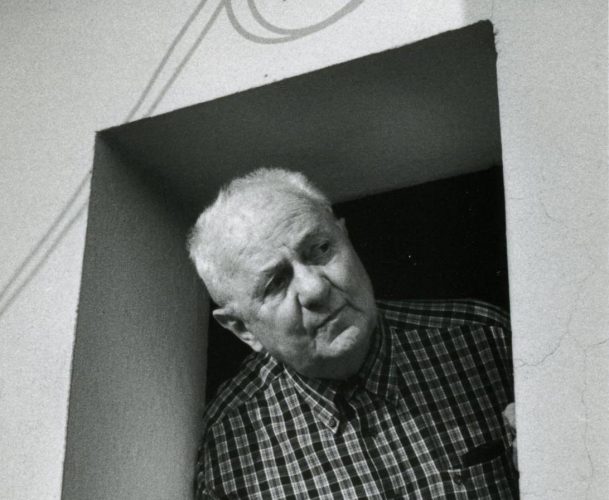Una scelta di poesie da Tolmino Baldassari, La néva (1980), a cui segue un saggio critico di Franca Mancinelli. Il libro è stato riedito da Raffaelli Editore nel 2016 e il saggio è la prefazione a questa riedizione.
I
abbiamo camminato nelle strade piene di polvere
ci ha fatto ombre un noce
il vento freddo che ci ha trovato da giovani
la luce che è passata per il canneto
l’aprile non c’è mai stato
abbiamo perduto il passo degli amici
della giostra grande ferma sul mezzogiorno
di un’ape nel giro stretto di un fiore
delle voci lunghe
del vento che ha giocato sempre più in alto
abbiamo chiamato qualcuno che non ha badato
per vedere quel pino quando nel mezzo dell’estate
si snoda lento nell’aria
o le sere che s’incontrano con la nebbia
le foglie delle pioppe silenziose nel canale
che poggiano la loro testa sul cuscino
guardando le lenzuola bianche fresche di bucato
il tremolio è solo fiamma di candela
ma nevica in un grande spiazzo
che si allarga sempre più
quando verranno gli amici a dire che ci siamo
battono le mani da lontano
cercano nell’aria gelida
il caldo della neve che circonda i muri
lo spiazzo si allarga ancora
alta la neve i lumi ti abbagliano
prima della guerra c’erano ancora le stelle
per la strada passavano i biroccini
il sonno arrivava sulla sedia
si riempiono d’acqua i fossi della strada
non ho più visto il merlo dal becco giallo
e Toni il falegname ma non di mestiere
che se la cavava a fare un po’ di tutto
sempre diceva vedrete che viene la guerra
e a me che non mi badava
perché ero un ragazzo
come stavo attento alle sue parole
come piantava i chiodi nelle assi
per lui si può dire un requiem e per i braccianti
che sfangavano una volta nel canale
rimasti a mani vuote
ma potevamo comprare la carbonella
hai voglia… eravamo ricchi
(la tua faccia tra le foglie o solo le foglie?
un sasso che gli piove sopra fermo nel cortile
quello che siamo noi quando suoniamo il violino)
una cane senza padrone
sempre ci veniva incontro scodinzolando
e quei tre galli che sul fare dell’alba cantano
il Sidin passava in bicicletta
il fazzoletto della trebbiatura intorno al collo
se dall’estate viene qualcosa che brucia
s’attorce intorno al pero guarda il cielo
[…]
III
[…]
qualcosa che sognavo che mi sono dimenticato
scivola per la riva nell’acqua chiara
o forse un sasso che avevo tirato nel fiume
ha fatto i cerchi
o il mare che dorme di notte fino laggiù
il respiro di un bambino vicino a riva
o le sere troppo calde che annaffiavano
odore di polvere bagnata
le nuvole che s’ammucchiano fanno dei ricci
e pensi che dietro ci sia il paradiso
gli angeli che soffiano con le gote gonfie
le trombe lunghe d’oro
e la vigilia di Natale il bianco della neve
quando si accendono le candele sulla tavola
io sopporto perfino il gioco delle carte
le ombre sono coperte nei sentieri
adesso il lampadario non vuole tremolare
la luce è ferma nelle camere fiorate
il treno passa di notte
intorno non c’è più niente che tu possa toccare
le braccia degli alberi scure di lassù
toccano terra
sentieri col respiro un po’ più avanti
aprono un lume sbiadito che gli occhi non vedono
e un giorno che di colpo ti abbandonano le mani
allora ti riduci in un cantone
lontano nessuno che ti veda
e poi muori solo
come un povero animale che si vergogna
la vita un sogno e i sogni restano sogni
I
en caminé int al strêdi pini d’porbia
u s’ha fat l’òmbra un cocal
e’ vent giazzé ch’u s’à truvê da zuvan
la lus ch’la j è pasêda pr‘e‘ canéd
l’abrìl ungn’è mai stê
en pérss e’ pas dj amìgh
dla giöstra grânda férma int e’ mezdè
d’un’éva int e’ zir stret d’un fiór
dal vósi lònghi
de’ vent che l’ha zughé sèmpar piò in êlt
en ciamê quaicadun ch’u n’ha badê
pr‘avdé che pen quânt che int e’ mëz dl’instêda
uss snóda lent int l’êria
o al séri ch’al s’incontra cun la nebia
al foi dal piöpi zeti int e’ canêl
ch’al pögia la su tësta int e’ cussen
guardènd i linzùl biench fresch ad bughéda
e’ tarmuléd l’è sól fiâmba d’candéla
mo e’ néva int un gran spiàzz
ch’uss slêrga sèmpar d’piò
quânt l’avnirà j amìgh a dì ch’ai sen
i sbat al mân dalòngh
i zérca int l’êria svidra
e’ chêld dla néva ch’la zircònda i mur
e’ spiàzz uss slêrga incóra
êlta la nèva i lom i t’imbarbaja
prèma dla guëra u j éra incóra al stëli
par la strêda e’ passéva i baruzzen
e’ sòn l’avniva int la scarâna
u s’impèss d’aqua i foss dla strêda
a n’ho piò vest e’ méral de’ bëch zal
e Töni e’ falignâm mo nö dl’amstìr
ch’uss sgavagnéva a fê un pô d’ignaquël
sempr‘e’ géva avdirì ch’e‘ ven la guëra
e me ch’u n’um badéva
parchè a séra un burdël
cum ch’a staséva atenti al su parôli
cum ch’e’ piantéva i ciud in sò int agli ëssi
par lo uss pö dì una réchia e pr‘i sbrazzent
ch’i slachéva una vôlta int e’ canêl
armëst a dent sgargnì
mo a putèma cumprê la carbunena
t’é voja a sèma sgnur
(la tu fazza tra al foi o sól al foji?
un sass ch’ui piôv in sò férm int la córta
quel ch’a sen nun quânt a sunen e’ viulen)
un cân sânza padron
sempr‘u s’avniva incontra scudazzènd
e chi tri ghël che int e’ fê dl’êiba i cânta
e’ Sidin e’ passéva in bicicleta
e’ fazzulèt dla tebia intórna a e’ cöl
se da l’instêda e’ ven quaiquël ch’e’ brusa
uss tôrza intórna a e’ pér e’ guêrda e’ zil
[…]
III
[…]
caicvël ch’a j insugnèva ch’am so smèngh
e’ sbresa par la riva int l’aqua cêra
o fòrsi un sas ch’èva tirè int e’ fiun
l’à fat i zirc
o e’ mêr ch’e’ dôrma d’nöta fina in chêv
e’ respir d’un babin tachê a la riva
o al sèri tröpi chêldi ch’i dacvèva
udòr d’porbia bagnêda
al nuvli ch’al s’amocia al fa in rez
e t’pins che d’drida ui sia e’ paradis
j enzal ch’i sofia cun al gôti gonfi al tròmbi lònghi d’ôr
e la vzilia d’Nadêl e’ biânch dla nèva
cvânt ch’u s’impèja al candèli int la têvla
me a supôrt parsena e’ zugh dal chêrti
agli òmbri agli è ciutêdi int i sintir
adës e’ lampadêri un vô tarmê
la lus l’è fèrma int al câmbri fiurêdi
e’ trèno e’ pasa d’nöta
intòrna u ngn’è piò gnit t’posa tuchêe
al brazi dj èlbar scur a là d’in êlt
al toca tëra
sintir cun e’ rispir un pô piò ‘vânti
j arves un lòm sbiavì che j oc in vèd
e un dè che d’böta u t’abandona al mân
alòra tat ardus int un canton
dalòngh nisun ch’it vega
e pu t’mur da par te
cumè un pôr animêli ch’us vargogna
la vita un sogn e i sogn j armasta sogn
***
La neve, il suo incanto che sospende lo scorrere del tempo, è lo sfondo di questo poemetto in tre sequenze di Tolmino Baldassari. Pubblicato nell’’82 per Forum/Quinta Generazion,[1] rappresenta un unicum e probabilmente il punto di massima intensità nel percorso del poeta di Cervia. È come se in questa particolare forma poematica Baldassari abbia trovato la possibilità di elevare la propria poetica, donandoci il più alto lascito che la sua capacità di accoglienza della vita ha tenuto in serbo. «Ogni singola poesia di Tolmino Baldassari sembra essere stata intensamente ascoltata», scrive Gianfranco Lauretano nella prefazione all’antologia da lui curata, che ne raccoglie l’opera (L’ombra dei discorsi, puntoacapo, 2010).[2] I suoi versi sembrano infatti quasi contenere e plasmare la materia del tempo. Nascono da un momento di contemplazione estatica in cui il suo fluire si arresta permettendo l’accesso a una dimensione altra. In questo stato il vedere si addensa e trapassa in visione: la scena quotidiana si apre, si dilata, immettendo nel cuore delle cose. La sua poesia sembra generarsi proprio da queste accensioni in cui il reale si manifesta. Appartiene a uno sguardo che ha saputo mantenersi nell’infanzia, in un contatto primigenio con il mondo. La precisione delle immagini non si origina dallo stratificarsi della scrittura e dal lavoro di lima, ma dall’intensità con cui Baldassari ha saputo attenderle e riconoscerle. I suoi versi conservano il fiato dell’oralità, la naturalezza di una parola che affiora alle labbra. Sono composti di una particolare qualità del tempo, dilatato fino a creare un passaggio tra la quotidianità e altre dimensioni. Transitano l’una nell’altra, intersecandosi, la veglia e il sogno (vedi ad esempio una poesia come E’ los dal méli pôrtagali, Il lusso delle arance), la realtà e la sua proiezione interiore (vedi un capolavoro come Canutir, Canottieri), la vita e la morte (e qui i riferimenti sono molteplici, perché il dialogo con l’oltre in questo poeta è alle radici della visione: basti rileggere testi come E’ cân, Il cane; Una nöta, Una notte; Un a un, Uno a uno; I vìdar, I vetri; Invéran vita, Inverno vita; In chêv de’ cantir, In fondo al campo). Baldassari affonda nell’esperienza del tempo fino a poterlo vivere attraverso porte comunicanti tra passato e presente, da cui può entrare e uscire, lasciarsi richiamare, sostare in ascolto tra due soglie. Nei suoi versi non affiora mai il sentimento della nostalgia, per la stessa ragione per cui quasi non si trova un passato compiuto e concluso (c’è l’imperfetto della rievocazione e del ricordo, il passato prossimo, molto raramente quello remoto): ciò che è depositato nella memoria, può tornare a un tratto presente. Esempi di particolari esperienze di percezione del tempo si possono leggere in poesie come I bév cun me j amigh (Bevono con me gli amici), dove nello spazio liminare della notte, la realtà è rarefatta e messa in dubbio dalla coscienza di quanto è già stato vissuto, o in La spighéva (Spigolava) dove le tre brevi sequenze in cui è divisa la poesia corrispondono ad altrettanti modi di relazionarsi con ciò che è trascorso, dalla presa di consapevolezza dell’azione devastatrice del tempo, alla rievocazione di un’immagine cara che si fa presente: la nonna piegata nel campo a spigolare si rialza. Questa azione, sorretta dalla forza della visione che l’ha strappata al vuoto, avviene sotto i nostri occhi, per un risarcimento che si compie attraverso la parola poetica. Il processo di restituzione inizia con un verso in cui Baldassari realizza una sorta di cortocircuito temporale, da cui si sprigiona quella particolare tensione immaginativa che illumina la sua poesia: «adës l’è têrd» («adesso è tardi»), scrive con quella sua potente semplicità capace di condensare in poche parole due dimensioni: il presente di una giornata lavorativa che anni fa giungeva al suo culmine, e quello della soglia da cui il poeta si è sporto a guardare.
a ngn’ò pinsê
che e’ temp e’ putes ingulê
la nòna ch’la spighéva int e’ cantir
int l’êiba tra j ùjum
a la gvardèva pighéda
ch’la strabighéva e’ sach lighé int un fiânch
adës l’è têrd
al parpajöti zali al vóla
li la stà sò
non ci ho pensato
che il tempo potesse ingoiare
la nonna che spigolava nel campo
all’alba tra gli olmi
la guardavo piegata
che trascinava il sacco legato a un fianco
adesso è tardi
le farfalle gialle volano
lei si rialza
Si potrebbe pensare che Baldassari abbia trovato nella poesia una lente per moltiplicare le possibilità dello sguardo. Può restituirci sovrapposte e congiunte immagini colte a occhio nudo e attraverso un cannocchiale rivolto dentro di sé, nelle densità buie della memoria. Con il poemetto La néva è come se abbia centrato un punto assoluto della visione. La neve è infatti legata a una condizione dell’esistenza liberata dallo scorrere del tempo. Riconduce a una dimensione infantile, di stupore attonito di fronte alla presenza delle cose, ci rivela a noi stessi, illuminati dal mistero dell’esistenza. I versi di Kobayashi Issa scelti come epigrafe al poemetto, contengono proprio questa esclamazione ferma. Il paesaggio bianco è lo sfondo su cui appaiono le immagini che condensano una vita, la sequenza in cui ci è dato vedere, al termine di una vicenda, la sua essenza. Il poemetto termina infatti con la morte solitaria di chi ha preso la parola, riconducendoci nello stesso spiazzo innevato da cui aveva preso avvio il visionario e frastagliato flusso narrativo.
La néva segue un filo che si svolge tra le sconnessioni e i repentini passaggi dell’inconscio. A presentarsi sono i fatti esemplari, quelli attraverso cui si illuminano di significato molti altri. Per questo la forma del poemetto non può che essere frammentaria: obbedisce all’intensità con cui le immagini si ripresentano alla mente, spinte dalla necessità di trovare un senso, di riconoscere una traccia nella propria esistenza. Stralci di paesaggio, figure, lacerti di storie, gesti, oggetti si stagliano con l’incandescenza di barlumi riemersi dalle profondità degli anni. La densità di vita di questi versi, l’energia che li sostiene, si genera per contrastare il vuoto che si apre a conclusione del poemetto. L’anonimo protagonista de La néva si ritrova infatti in uno spazio di solitudine assoluta, in cui la morte è preannunciata dalla perdita del contatto con le cose («e un dè che d’böta u t’abandona al mân», «e un giorno che di colpo ti abbandonano le mani»). Quest’opera è un tentativo di tenere a bada la realtà della fine con la tensione del proprio immaginario, ma è anche un tentativo di prendere congedo dalla vita, un privato e corale requiem. La parola è affidata a un personaggio in cui si proiettano tratti autobiografici del poeta (la sua vicenda è rievocata sullo sfondo di una piccola comunità della Romagna, segnata dallo spartiacque del conflitto mondiale), ma la trama di questa esistenza singolare è un fittissimo intreccio di presenze: soprattutto figure concrete di familiari e paesani, ma anche evanescenze intermittenti della visione o figure investite di un’aurea salvifica o magico fiabesca.[3] Una stessa pietas nomina direttamente gli abitanti del borgo come i familiari (Toni il falegname, Sidin in bicicletta, il babbo, il fratello Lino), sia che riemergano con un lembo della propria storia chiedendo ascolto (la Pia de’ Fin, la Candina Bondi), oppure sfilino per un attimo come comparse, sono ugualmente impresse per sempre sul nastro della memoria. Riaffiorano alla luce della parola poetica che le richiama al presente, facendole partecipi della rievocazione che sta avvenendo, fino a interpellarle direttamente, come in questi versi che riscuotono dal silenzio, quasi un’invocazione: «te ba t’si férum cun e’ parpignan / i cavël it camena incòra ad dninz» («tu babbo sei fermo col perpignano / i cavalli ti camminano ancora davanti»). Un brivido ci fa avvertire la presenza del padre, ma appena il mondo abitato insieme inizia a prendere consistenza, come in un presepio di cui si possono ricollocare esattamente luoghi e figure, ecco subito immettersi nella scena quella tonalità doppia, oscillante tra la realtà del ricordo e la percezione dell’oltre, che costituisce una delle cifre stilistiche della poesia di Baldassari: «an so dut sia andê pr e’ scur dla strêda» («non so dove sei andato nel buio della strada»). Queste fenditure che si aprono a un tratto in cui le cose sembrano darsi nitidamente e insieme immergersi nel mistero, sono l’intelaiatura finissima che sorregge La néva. Da qui sgorga l’intensa magia che attraversa e pervade il poemetto. È fatta di una particolare qualità di amore depositato negli anni che permette di sentire la presenza di chi non c’è più. Possiamo immaginare questi versi pronunciati dentro la cerchia di quella piccola comunità su cui è caduta una cortina di neve, in quell’intimità che riconosce l’altro anche senza vederlo, proprio come le parole che da porta a porta, nei borghi, si scambiavano le donne al buio. D’altronde il poemetto si apre all’insegna di un cammino condiviso: la presenza della coralità è così forte da accompagnarci fin sulla soglia dello spiazzo di neve, inizio e termine del viaggio.[4] È soltanto allora che comincia a emergere, dal noi, la singolarità del soggetto narrante de La néva. Ma è anche un altro tipo di fede a illuminare questi versi, quello per la poesia capace di agire nella realtà e modificarla, come indica il suo etimo (poiein, fare). Per Baldassari «una parôla l’è un fat ch’e’ suzéd» («una parola è un fatto che succede»). Sorge dai varchi che si aprono nell’esistenza, risarcisce le perdite. La néva è scritta anche per farsi voce di chi è stato cancellato dalla storia ufficiale e “chiama nella memoria”, preme nel presente, riaffiorando «int i scurs e int e’ môd d’rìdar» («nei discorsi e nel modo di ridere») di chi di quella vita resta testimone. I versi di Tolmino assorbono queste fessure che diramano nel quotidiano, nascono dall’ascolto profondo di una comunità che, dopo il secondo conflitto mondiale, si è ritrovata con i vuoti lasciati dai tanti scomparsi[5] e un mondo che nel giro di pochi anni sarebbe stato travolto, dimenticato: «mo adës e’ fugh l’à ormài brusé gnacvël / tot cvel ch’u j éra stê nisun u s’l’arcôrda» («ma adesso il fuoco ha ormai bruciato tutto / tutto quello che c’era nessuno se lo ricorda»). È dalla consapevolezza di questo presente spoglio, azzerato, che in Baldassari scocca la scintilla de La néva. Come per altri autori della sua generazione (tra i nati negli anni ’20 basterà ricordare Guerra, Pasolini, Zanzotto, Volponi), l’esperienza di Baldassari è segnata da una faglia epocale. In questo poemetto è una precisa demarcazione da cui prende avvio il flusso rievocativo: «prèma dla gvëra u j éra incóra al stëli / par la strêda e’ paséva i baruzen» («prima della guerra c’erano ancora le stelle / per la strada passavano i biroccini»). Ma è anche nell’immaginario e nella lingua che viene tracciato un profondo confine. Nei frammenti che il soggetto riporta alla luce come essenza e significato della propria vicenda, si stagliano alcune sequenze fondamentali che si possono seguire come l’intermittente traccia di un romanzo di formazione in versi: oltre a quella erotica dell’incontro con la mondina, e quella onirica dell’incontro con il fratello morto,[6] risalta quello che appare come il primo avvertimento della morte nel suo indissolubile legame con la vita, una percezione che resterà nel fondo dello sguardo e che si può leggere anche come una sorta di iniziazione poetica:
mo l’è stê döp cvânt che la Pia de’ Fin
u la ciapè i tedeschi nt e’ canéd
che un mëẓ ad me l’à cminzê a scor cun chj ètar
e sól cl’êt mëz e’ sint l’umór de’ pân
a j ò cminzê a gvardê j usel ch’i môr
a la matena cvânt e’ spunta e’ sól
ma è stato dopo quando la Pia de’ Fin
la presero i tedeschi nel canneto
che una metà di me ha cominciato a parlare con gli altri
e solo l’altra metà sente il sapore del pane
ho cominciato a guardare gli uccelli che muoiono
la mattina quando spunta il sole
Richiamato dalle perdite che squarciano il tessuto della comunità, plasmato e formato da questi vuoti, il protagonista de La néva si sporge fino quasi a tastarne la consistenza, ad auscultarne il suono:
cvânt che i tedesch i la purtéva vi
la spariva ingulêda da e’ disten
ch’l’éra un svùit e ch’l’éra un gnit
mo da che gnit l’ariva la su vósa
quando i tedeschi la portavano via
spariva ingoiata dal destino
che era un vuoto e che era un nulla
ma da quel nulla arrivava la sua voce
La poesia è un fare che può porre rimedio al fatto della morte e al silenzio della storia. Possiamo leggere così l’affermazione di poetica incastonata nella trama di questo poemetto.[7] Ma anche ricordando quella dimensione di attesa e di apertura in cui, per Baldassari, la parola “succede”, accade quasi nonostante noi, come la vita. Al poeta non spetta altro che creare, nell’intensità dell’ascolto, lo spazio in cui lasciarla affiorare. Con questo poemetto siamo proprio al centro di quel luogo. Dopo le prime strofe introduttive, gli ultimi versi della terza aprono infatti i contorni entro i quali vedremo sfilare frammenti e sequenze tra sogno e memoria: «e’ termuléd l’è sól fiâmba d’candéla / mo e’ néva int un gran spiaz / ch’us slêrga incóra» («il tremolio è solo fiamma di candela / ma nevica in un grande spiazzo / che si allarga sempre più»). Questo luogo bianco dai perimetri mobili, conterrà ogni storia e vicenda evocata. Qui ci ritroveremo alla fine, con il protagonista rincantucciato in se stesso e pronto alla morte. La struttura de La néva è circolare;[8] tutto ciò che accoglie, i moti della mente, il suo brulicare, si svolge attorno a un punto fermo. Possiamo riconoscere la forma di questo poemetto nelle immagini che, nella seconda strofa, rappresentano l’inevitabile perdersi della vita nel tempo, tra movimento e stasi: la «giöstra grânda férma int e’ meẓdè» (la «giostra grande ferma sul mezzogiorno»), «un’éva int e’ ẓir stret d’un fiór» («un’ape nel giro stretto di un fiore»). E pensare alla chioma di un albero attraversato dal sole: questa intelaiatura finissima e mobile da cui filtra la luce assomiglia all’intreccio sottile di diversi piani del tempo, percezioni della memoria, lampi della visione. È una struttura fragile e aperta, capace di accogliere tutto, dai riflessi e ombre nella natura, ai minimi trasalimenti della vita quotidiana, alle cicatrici aperte dalla storia (viene evocata l’impiccagione dei partigiani, il passaggio dei deportati, la vicenda ebraica). Ogni immagine è trafitta dallo stesso bagliore: una foglia bagnata ha la stessa pregnanza di fatti che aprono drammatici squarci. Questa trama sottile raccoglie le tracce di drammi e ingiustizie, ne ospita i vuoti, riconducendoli dentro il movimento e la luce della vita. Così da un fazzoletto lasciato sull’aia, unico segno di un’esistenza travolta, affiora una voce, e poi «un cunzért ad véli culurêdi» («un concerto di vele colorate»). Un altro esempio del serrato intrecciarsi tra silenzio e parola, memoria e presente, solitudine e coralità, che intesse questo poemetto, è tra il termine della prima sequenza e l’inizio della seconda, in uno dei più suggestivi passaggi tra la pienezza debordante di vita del mondo evocato, e la fissità di un’interrogazione radicale, che mette al setaccio l’intera esistenza: «i burdel cun di zigh i fa la sbresa / un zet da néva // j amigh cvânt avnirài?» («i ragazzi strillando giocano alla scivolata / un silenzio da neve // gli amici quando verranno?»).
caicvël ch’a j insugnéva ch’am so smèngh
e’ sbresa par la riva int l’aqua cêra
o fórsi un sas ch’éva tiré int e’ fiun
l’à fat i zirc
qualcosa che sognavo che mi sono dimenticato
scivola per la riva nell’acqua chiara
o forse un sasso che avevo tirato nel fiume
ha fatto cerchi
Nelle strofe conclusive del poema torna un’immagine che sembra rispecchiare la sua forma, il suo trasognato fluire che è forse soltanto il tracciato di un cerchio. Flusso evocativo e movimento concentrico attorno a una sorgente di stupore e di rivelazione, sono infatti due vettori che si intersecano dando origine al moto apparente de La néva.
Affiora a tratti il trascorrere delle stagioni, percepite attraverso i cambiamenti della natura, insieme alla vita quotidiana di una comunità, un po’ come nel poemetto L’Appennino contadino di Paolo Volponi.[9] Ma presto ci si accorge che la sola stagione che fa da sfondo a ogni avvenimento è l’inverno; il calore dell’estate non è che un breve ricordo, pronto a volgersi nel freddo:
la góla ch’cânta dentr un raẓ ad sól
e pu la nebia svidra int i cavel
i èlbar i sgozola candéli arlusenti
[…]
u s’è fat têrd t’vé a ca ch’u ngn’è piò e’ sól
l’aqua int i pi lat mâgna al didi tinchi
la gola che canta dentro un raggio di sole
e poi la nebbia gelida nei capelli
gli alberi sgocciolano candele lucenti
[…]
s’è fatto tardi vai a casa non c’è più il sole
l’acqua nei piedi si mangia le dita rigide
L’avvicendarsi delle stagioni è un’illusione data da alcune annotazioni che segnano il passaggio del tempo, in realtà siamo di fronte a un nastro interrotto, che ci riporta allo stesso paesaggio invernale. Le tre sequenze che formano il poema si concludono infatti tutte con un ritorno nella neve. L’effetto è quello di un lungo fermo immagine su cui si proiettano riflessi che danno l’apparenza del trascorrere. Possiamo vederlo ad esempio nella prima sequenza dove, dopo la descrizione di una forte nevicata, ci ritroviamo due strofe dopo con l’annuncio dell’arrivo di un’altra stagione, che non fa che ricondurci a un altro inverno: «e’ néva fôrt e’ chesca di grènd blëch / […] / e pu l’avnè un’êta stason / i paséva pr al strêdi incaparlé / e’ fred l’èra int agli ösi» («nevica forte cadono larghe falde» / […] / e poi venne un’altra stagione / passavano per le strade avvolti nel mantello / il freddo era nelle ossa»). La neve è al di sotto di ogni immagine evocata: ogni barbaglio non può che ricadere nel vuoto, risorgere, e ricadere di nuovo, rinviando a quello spazio bianco da cui affiora la parola poetica.
In questo filmato che si svolge sotto ai nostri occhi, è fondamentale l’azione della luce: dal tremolio di una candela, a lumi che nella neve abbagliano, poi si fanno lontani nel buio e infine sbiadiscono. Con il consumarsi della luce termina il poemetto.[10]
Ogni verso si è confrontato con la fine, stagliandosi contro il bianco della pagina-neve, sospinto da un ritmo serrato che chiama a portare in salvo quanta più vita possibile. Non c’è tempo per enjambement o per le pause dell’interpunzione. In tutta La néva affiorano soltanto alcuni punti interrogativi che a fine verso si aprono nel silenzio, senza cercare o aspettare risposta.
La radura innevata a cui siamo ricondotti, non è soltanto un solitario rifugio in cui lasciarsi raggiungere dalla morte, ma anche, forse, la possibilità di ritorno in un luogo autentico, di pienezza e vicinanza con gli altri: «la nèva ch’ la ciutes tot ignacvël / e sota dês la vósa par truvês», «la neve che coprisse tutto / e sotto darci il richiamo per ritrovarci». La vita è un sogno, scrive Baldassari congedandosi da questo poemetto[11] e ricordando forse, oltre a Calderón, l’epigrafe sulla tomba di un nostro eroe che, privato della materia dei suoi sogni, incarnò in sé ciò che era stato distrutto tanto da avere «la gran fortuna di viver matto e di morir savio». Allo stesso modo del cavaliere della Mancia, il poeta «cumè un sânt indurment» («come un santo addormentato»),[12] sta nella vita, la trasforma, attraverso la forza incandescente del sogno.
Franca Mancinelli
[1] La néva. Poesie (1974-1981), con un saggio di Franco Brevini, Forum/Quinta Generazione, Forlì 1982. Oltre al poemetto omonimo il volume raccoglie una scelta di testi dai primi tre libri di Baldassari.
[2] T. Baldassari, L’ombra dei discorsi. Antologia 1975-2009, a cura di G. Lauretano, puntoacapo, Novi Ligure 2009. Tutte le citazioni dei versi di Baldassari, se non specificato diversamente, fanno riferimento a questa edizione.
[3] Vedi ad esempio« l’ânzal» («l’angelo»), «e’ babin ch’e’ va in êlt in só int al nuvli» («il bambino che va in alto sulle nuvole»), «un cavalier sech cumè un stlonc» («un cavaliere secco come una scheggia di legno»), l’amico poeta catalano definito «fradël» («fratello») e «mêgh» («mago»). Tra le figure concrete spiccano anche due personaggi storici (Gramsci, Luther King).
[4] Ad apertura de La néva, la presenza del coro è evidenziata da tre azioni collocate in anafora a inizio di strofa: «en caminé» («abbiamo camminato»), «en pérs» («abbiamo perduto»), «en ciamê» («abbiamo chiamato»). In questa sequenza si può riconoscere, condensata, la traccia del poemetto, ossia quella di una vita (in Baldassari il verbo “chiamare” è spesso associato ai morti – vedi ad esempio la poesia L’òmbra di scurs, L’ombra dei discorsi da E’ zet dla finëstra, Il silenzio della finestra, Book, Castel Maggiore 1998).
[5] Vedi in particolare i versi: «e j òman i n’è piò fili d’cariôli / int e’ rivêl fiun / u j éra al maigariti al ni è piò / chi cânta adës chi sbroja la matasa? / chi ciôta piò i babin ch’i s’è s-ciute?» («e gli uomini non sono più file di carriole / sull’argine del fiume / c’erano le margherite non ci sono più / chi canta adesso chi sbroglia la matassa? / chi copre più i bambini che si sono scoperti?»).
[6] L’importanza di queste sequenze è evidenziata anche dall’uso dei pronomi personali: la mondina insieme al padre è l’unica figura a cui il protagonista si rivolge con il tu; il fratello, insieme al padre, è l’unica figura a cui è riservato, dopo le tre strofe iniziali, il noi.
[7] Oltre a quella precedentemente citata, una dichiarazione di poetica si può trovare implicita anche in questi versi che racchiudono una sorta di apprendistato: «cum ch’a staséva atenti al su parôli / cum ch’e’ piantéva i ciud in so int agli ësi» («come stavo attento alle sue parole / come piantava i chiodi nelle assi»). Nel magistero di “Toni il falegname” si possono riconoscere i caratteri distintivi della poesia di Baldassari, quella rigorosa semplicità frutto di un’umile dedizione alla parola.
[8] Una struttura circolare, legata all’immagine della neve, torna significativamente in un altro libro in cui Baldassari ripercorre le tessere della propria esistenza: Qualcosa di una vita, posta fazione di Alberto Bertoni, edizioni del bradipo, Lugo 1995. Questa raccolta di brevi prose può essere letta anche come cartina di tornasole degli elementi autobiografici presenti ne La néva. Tornano infatti luoghi e figure presenti nel poemetto come: «il povero Lino» (p. 5), il padre birocciaio (p. 7), il «povero Mario, morto in mare»; il duomo di Colonia e l’Ungheria sognata (p. 40).
[9] P. Volponi, Le porte dell’Appennino, Feltrinelli, Milano 1960, ora in Id., Poesie 1946-1994, a cura di E. Zinato, Einaudi, Torino 2001.
[10] Questa luce compare in ogni sequenza de La néva. Nella prima la fiamma tremante di una candela apre lo spazio da cui sorge la vicenda narrata e conduce poco dopo a lumi che abbagliano nella neve alta: da questa cecità momentanea ha propriamente inizio la visione rievocativa. Al termine della seconda sequenza tornano i lumi: sono nel buio ora, e si vedono «ormài dalòngh» («ormai lontani»). Come in un’anticipazione della fine, il protagonista chiude gli occhi. Verso la conclusione de La néva c’è un lampadario che non vuole tremolare e la sua luce ferma che, poco oltre, nell’aperto della notte, si risolve in un «lòm sbiavì che j oc in véd» (un «lume sbiadito che gli occhi non vedono»).
[11] Per interpretare il carattere di questo sogno vedi anche la prosa conclusiva di Qualcosa di una vita, cit.,: «Vorrei un bel sogno di neve. Vorrei che scendesse la neve della mia infanzia, con tutta la gente d’allora intorno a me e io con loro […] Cadrà ancora la neve, e noi ce ne andremo uno a uno, nella sua pace». Per la congiunzione di sogno, neve e rievocazione dell’infanzia vedi anche la poesia Chi éra Nuvoloni? (in T. Baldassari, Al rivi d’êria, Il Ponte, Firenze 1986).
[12] T. Baldassari, L’éva: poesie in dialetto romagnolo, prefazione di G. Lauretano, Pier Giorgio Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN) 2002.